
PRANZO D’ANNIVERSARIO
Un racconto di Francesca Diano
Lisciò con delicatezza la bella tovaglia di fiandra color crema, attenta che le dita screpolate non ne tirassero qualche filo. Aprì l’anta inferiore della grande credenza di noce intagliato e prese i preziosi piatti di porcellana Ginori – marchio precedente alla fusione con Richard nel 1896 – dall’orlo smerlato, decorati con piccoli festoni azzurri e fiorellini rosa e oro.
Un piatto piano per il Dottore, uno per la Signora, uno per sé. Un piatto fondo per il Dottore, uno per la Signora, uno per sé. Calcolò la precisa posizione dei piatti sul tavolo rotondo, in modo che fossero perfettamente equidistanti. A lato pose i tovaglioli ripiegati in un perfetto triangolo.
Aprì il cassetto di destra della credenza, dove le posate d’argento erano ordinate nei loro sacchetti salvapolvere. Le impugnature panciute erano cesellate a decori floreali. Un regalo per le nozze della Signora e del Dottore.
Un coltello, due forchette, un cucchiaio, una forchettina, un coltellino da frutta e un cucchiaino da dolce per il Dottore, poi per la Signora e poi per sé.
Aprì l’anta superiore della credenza e ne trasse sei bicchieri di cristallo, tre grandi per l’acqua e tre più piccoli per il vino e li pose di fronte ai piatti, leggermente spostati sulla destra, in modo che il bicchiere da vino fosse in linea col bordo dei piatti. Come le aveva insegnato la Signora.
In una boccia di cristallo boemo sistemò mazzetti di rose bianche contornati di edera, che aveva colto in giardino. La trasparenza lucente del cristallo e la cupezza delle foglie d’edera esaltavano il bianco vellutato dei petali di rosa. Arretrò e contemplò soddisfatta l’opera. Tutto era perfetto.
Dalla cucina arrivava il profumo del timballo di riso che stava finendo di cuocere in forno, cui si fondeva l’aroma pungente del fegato alla veneziana, creando un composto aromatico variegato e singolare.
Il timballo di riso, o sartù, come lo chiamava la Signora, era stata una delle prime ricette che le aveva insegnato. La preparazione laboriosa ne faceva una pietanza adatta a ricorrenze speciali, proprio come questa. Si era alzata prima dell’alba per prepararlo. Strati di riso condito, ragù, polpettine di carne di maiale ben rosolate, uova sode, fettine di mozzarella, pisellini freschi. Non aveva dimenticato nulla. Poi aveva spolverato la superficie del sartù con abbondante pangrattato e parmigiano e aveva infornato.
Alla Signora piaceva moltissimo, le ricordava la sua terra. Anche il Dottore l’apprezzava, ma gradiva non meno anche il suo figà aea venessiana, col suo aroma stuzzicoso. <<Un piatto semplice, popolano>>, diceva il Dottore, <<ma che gusto!>>
Ormai era tutto pronto. Portò in tavola la caraffa con l’acqua fresca e una bottiglia di Amarone, il preferito del Dottore con qualunque pietanza.
<<Dottore!>> chiamò Antonietta. <<Vieni che è pronto>>, disse, portando in tavola il sartù fumante.
*
Affrontando un lungo viaggio per risalire la penisola, il Dottore e la Signora erano arrivati nel piccolo paese della Bassa padovana poco dopo la guerra, e il Dottore, che era farmacista, aveva preso possesso della nuova farmacia di cui era diventato titolare. Un paese che era un puntino sulla carta geografica, quasi invisibile incrocio fra tre province, le cui uniche vette in un paesaggio piatto piatto erano un matitone di settanta metri su cui, proprio quell’anno, era spuntata una pianta di fico – ghe xé un figaro sora del campanile, aveva gridato il sacrista una mattina d’afa quando aveva alzato gli occhi al cielo – piantato accanto al suo chiesone, così grande da poter contenere buona parte degli abitanti. Soprattutto da quando i giovani, appena finito il conflitto, avevano preso ad emigrare in cerca di maggiori opportunità. Una piazza, lo spaccio con l’insegna DROGHE E COLONIALI, due botteghette, la farmacia, due osterie, l’ufficio postale e l’Adige che serviva da placido confine del paese e della provincia. E del mondo.
Il Dottore e la Signora si erano subito rivolti al parroco perché trovasse loro una brava ragazza, pulita e onesta che andasse a fare la domestica. La madre di Antonietta tirava avanti facendo qualche mestiere in canonica e il parroco si mise una mano sul cuore. Così, a poco più di tredici anni, era andata a servizio. L’aria selvatica, i modi bruschi, gli occhi che non abbassava mai quando le rivolgevi la parola, la facevano apparire molto più grande della sua età. Ma aveva uno sguardo intelligente, perciò fu giudicata adatta e poi la Signora pensava che l’avrebbe potuta istruire come piaceva a lei. Nonostante l’ignoranza, sarebbe diventata una buona domestica, anche se all’inizio facevano un po’ fatica a capirla, con tutte quelle parole in dialetto. Ma Antonietta, che di imparare non aveva paura, si mise in testa fin dall’inizio di parlare come il Dottore e la Signora, che avevano studiato e venivano dalla città del Papa.
<<Hai la stessa età di quando si è sposata la mia nonna>>, le aveva detto una volta il Dottore.
<<A tredici anni??>> aveva ribattuto Antonietta con aria incredula.
<<Sì, ma era a metà ‘800, al Sud. Si usava. Il nonno era medico e aveva trent’anni. Quando il nonno andava a visitare i suoi pazienti e lei rimaneva da sola, prima di avere i figli, giocava con le bambole.>>
Beata lei, che almeno aveva il tempo di giocare, pensò Antonietta. Chi l’aveva mai vista una bambola?
Abituata all’unico stanzone abitabile del cason lungo il canale poco fuori del paese, in cui viveva con padre, madre e fratello, con cesso esterno, uno sputo d’orto e qualche gallina, l’appartamento del Dottore le parve il palazzo del re. Tutte quelle stanze, e addirittura un bagno dentro casa, con il lusso dello sciacquone…
Un anno dopo il loro arrivo, il Dottore e la Signora andarono ad abitare nell’appartamento che avevano fatto costruire sopra la farmacia. Qui di bagni ce n’erano due e perfino una lavanderia e, per non fare avanti e indietro tutti i giorni, Antonietta si trasferì definitivamente da loro, in una stanzetta dietro la cucina.
Per la prima volta nella vita aveva un posto tutto suo in cui dormire da sola. Le parve impossibile essere riuscita a scappare dalla miseria e dalla violenza del padre ubriacone e manesco. La madre e il fratello, un povero ritardato che tutti additavano come lo scemo del paese, anche se con un certo affetto ruvido, se ne liberarono quando l’avvinazzato finalmente, in una sera di nebbia che pareva bava di lumaca, finì in un fosso ruzzolando dalla bici sgangherata e, pieno di vino, finì per affogare in tre palmi d’acqua fetida. Non fu pianto né rimpianto.
Antonietta non era una da lacrime e nemmeno di molte parole. Aveva imparato ad affrontare la vita a testa bassa e muscoli tesi, pronta a lottare da sola per la sopravvivenza. E di lavoro in casa del Dottore e della Signora ce n’era da fare, perché anche la farmacia andava tenuta lustra e impeccabile. Ma c’era anche da mangiare e Antonietta mangiava per tutte le generazioni di morti di fame da cui discendeva. Una fame antica, che niente pareva soddisfare. Per quanto mangiasse, non metteva su nemmeno un grammo. Pelle muscoli e ossa.
Fu il Dottore a mandarla dal medico condotto per capire il motivo di questa voracità dagli effetti invisibili. “Ipertiroidea”, disse il medico, “ma per il resto sana come un pesce.” Ma Antonietta sapeva che la sua fame veniva da una vita di stenti, di miseria, di denutrizione che aveva tormentato i suoi genitori, i suoi nonni, i suoi bisnonni e chissà quante altre generazioni di disperati. Veniva da quelle campagne che ai suoi avi braccianti non avevano reso mai nulla. Veniva da un buco nero che dal passato allungava le sue ombre come grinfie. Veniva da donne che s’erano rotte la schiena ad arrangiarsi per sopravvivere a una vita che le colpiva e si riproduceva come una maledizione. Ce l’aveva negli occhi enormi, un po’ sporgenti, quella fame, che parevano sempre accesi, anche quando dormiva. E alle cinque del mattino, quando si alzava, erano già belli e spalancati come non li avesse mai chiusi. Perciò. quello che non le riusciva di mangiare, se lo conservava sotto il letto, nella disgraziata evenienza che quella fortuna non durasse.
Avevano voglia il Dottore e la Signora a dirle che nessuno l’avrebbe privata del pasto successivo. Lo capiva con la testa, anche se il dubbio le rimase per un bel po’, ma vallo a dire allo stomaco e all’angoscia che non l’abbandonava mai. Eppure, per la prima volta, si sentiva parte di una famiglia; come se poi avesse mai saputo cosa fosse una famiglia.
Il Dottore e la Signora, non più giovani, non avevano avuto figli e le volevano bene. Non che non fossero esigenti, la Signora soprattutto, ma erano buoni e non la maltrattavano. Nella loro casa, fra le persone, esistevano dei fili che le tenevano legate. Il Dottore aveva un grande rispetto e affetto per la Signora e la Signora parlava del Dottore con devozione.
<<Ha inventato una medicina che prima non esisteva, sai>>, le disse. <<Una medicina che fa bene al fegato, un epatoprotettore. Purtroppo non ha fatto in tempo a brevettarla e gli hanno rubato la formula.>> E Antonietta, che badava molto al modo in cui la gente diceva le cose più che a quello che diceva, capiva che in quella frase, di cui ignorava il significato, c’era qualcosa di brutto, di triste, che il Dottore aveva subito. E che forse spiegava lo sguardo che pareva aver perso qualcosa che non si poteva ritrovare.
A casa sua invece, di fili che tenevano legate le persone non ce n’erano. Il padre sempre a bere e a menare le mani, emetteva solo urli, porchi o bofonchi. La madre abbrutita dal lavoro, dalle busse e dal far quadrare quel poco che entrava, usava il fiato residuo per qualche monosillabo. Il fratello pareva non vedere nemmeno quello che gli succedeva intorno.
Quanto sarebbe durata la sua fortuna? Non poteva permettersi di perderla. Di certo in quella stamberga non sarebbe tornata mai più.
<<Fati, no paroe, fati no paroe>>, ripeteva continuamente fra sé e sé il povero infelice che aveva per fratello, percorrendo a piedi, instancabile, le strade nebbiose d’inverno e addentate dal sole l’estate, che tagliavano la pianura come ferite, guidando a mano il relitto di bicicletta del padre, che aveva recuperato dal fosso. Dove avesse sentito quella frase nessuno sapeva. Forse durante una predica in chiesa o da qualche aspirante sindacalista all’uscita dell’osteria. E il soprannome Fatti gli rimase attaccato, a sostituire un nome proprio che nessuno ricordava.
Nonostante lo sguardo assente di Fatti, Antonietta non aveva mai pensato che fosse davvero scemo, ma solo che vivesse in un suo mondo felice in cui nessuno poteva raggiungerlo. Un mondo in cui il bianco era bianco e il nero era nero. In cui non c’era spazio per le sfumature che imbrogliano la vita degli uomini. Per cui quel motto ossessivo divenne per lei fondamento e guida. Il mondo del Dottore e della Signora, che lo aiutava in farmacia, era un mondo che le appariva bianco, proprio come il camice che il Dottore indossava e come il bancone e gli scaffali che contenevano le medicine.
Era emersa dal nero e non ci sarebbe tornata mai più.
Il Dottore e la Signora erano primi cugini e per sposarsi avevano dovuto chiedere la dispensa al Papa. Anche se la Signora le diceva che di figli ne avrebbe voluti, Antonietta sapeva che da unioni del genere nascono solo dei mostri e quindi era un bene che non ce ne fossero stati. Avevano però una nipote cui erano molto affezionati e che, quando vivevano a Roma, avevano cresciuto in casa loro. Ormai era sposata e li veniva a trovare raramente. La Signora avrebbe voluto vederla più spesso e, anche se non lo diceva, Antonietta capiva che quello era un tarlo che aveva nel cuore.
La nipote non era gentile come i suoi padroni. Quando veniva con il marito a trovare gli zii, in genere per Pasqua, la trattava da serva, la ignorava e le rivolgeva la parola solo per darle degli ordini.
<<Io ho solo la terza elementare>>, si lamentava Antonietta con la Signora, <<però non mi piace che vostra nipote mi tratti così.>>
<<Hai ragione Antonietta, ma devi avere pazienza. Viene da Roma e ti vede come una contadinella. Non si rende conto che per noi sei come una figlia.>>
Antonietta scrollava le spalle, convinta che forse se ne rendeva anche troppo conto.
<<Devi stare attenta a quella là, zia>>, aveva detto la nipote a Sara.
<<Perché? È una brava ragazza e, anche se ha visto tanta povertà, è onesta.>>
<<È molto sveglia e fra un po’ diventerà grande abbastanza. Non vorrai che poi si ripeta quello che è successo a Roma.>>
<<Per carità di Dio!>> aveva detto la zia. <<Non un altro scandalo… ma quella era una zoccola, una furbona e lo zio si è fatto abbindolare dai suoi scondinzoli.>>
<<Lo zio si fa abbindolare troppo facilmente, ma se la tua gelosia non fosse così ossessiva, se tu non lo soffocassi tanto…. guarda, adesso l’hai costretto a finire in questo buco, lontano da tutto, per le tue ossessioni. Lo sai che i cani non vanno mai tenuti a una catena troppo corta. Poi si ribellano e ti mordono le mani.>>
<<Ma come ti viene in mente questo paragone?>> La zia era inorridita.
<<Qui stiamo bene, stiamo tranquilli. E poi Antonietta poverina è tutta pelle e ossa, non hai visto? Che vuoi che gli interessi?>>
<<Tu comunque stai attenta>>, le aveva ripetuto la nipote.
Il tarlo così era stato insinuato, a tenere compagnia all’altro, ma la Signora cercava di scacciarlo, insieme a tanti altri fantasmi. Se avessero avuto dei figli, se lei non fosse stata più vecchia del marito, se lui non fosse stato così bello che pareva un divo del cinema. Dicevano che somigliasse a Tyron Power. Se non l’avesse sposata per riconoscenza, perché orfano dei genitori e, solo al mondo, era stato accolto in casa degli zii, i genitori della Signora, come un figlio e lei aveva passato da un pezzo l’età da marito.
Era soltanto un uomo debole, molto debole. Lo si vedeva da quella bocca morbida e carnosa, languida, quasi molle, con gli angoli leggermente rivolti all’ingiù. Ma lei non poteva sopportare l’idea che potesse innamorarsi di qualcuna, che tutte quelle donne di cui era circondato nella grande farmacia di Roma potessero abbindolarlo. Poi era scoppiato lo scandalo. La commessa sedotta, le chiacchiere, la vergogna. Le era sembrato di morire. Gli aveva fatto delle scenate terribili. Era arrivata a controllargli i minuti di strada fra la farmacia e casa. Aveva minacciato il suicidio. Per mettere tutto a tacere, per il quieto vivere, il Dottore aveva acconsentito a lasciare la farmacia sul Corso, il laboratorio in cui conduceva le sue ricerche, i suoi esperimenti, tutto. A seppellirsi vivo con lei in una bara nel mezzo del nulla.
Qui almeno, in quel buco di paesino in mezzo alle campagne, sul confine di tutto, non avrebbe avuto occasioni e, nonostante le insinuazioni della nipote, la Signora sapeva che Antonietta non sarebbe stata un pericolo. Troppo selvatica, troppo rozza, troppo segaligna. Con quei suoi modi spicci che non conoscevano civetterie.
Poi il Dottore cominciò a bere troppo. In pubblico nessuno l’aveva mai visto ubriaco ma la sera, dopo la chiusura della farmacia, si metteva a bere già prima di cena ascoltando Corelli, Mozart, Sibelius, Respighi. Quand’era ora di andare a letto parlava con la bocca impastata e non si reggeva bene sulle gambe. E allora Antonietta doveva aiutare la Signora a metterlo a letto, perché nemmeno la Signora si sentiva ormai tanto bene. In pochi mesi era dimagrita moltissimo e le mancavano le forze.
Quando il Dottore sbagliò le dosi di una preparazione galenica e mancò poco che non provocasse dei danni seri, Antonietta decise che non poteva lasciare che il suo nome e la sua reputazione venissero distrutte. Quella era la sua famiglia, lì era cresciuta, lì aveva trovato da mangiare, da aiutare il fratello rimasto solo dopo la morte della madre, lì aveva potuto perfino mettere da parte qualche risparmio per la vecchiaia. Come da giovane faceva col cibo sotto il letto. Forse, alla fine, nemmeno lì tutto era bianco, anche lì il nero si insinuava sfumando nel grigio. Ma forse, alla fine, nel mondo di bianco proprio bianco non ce n’è.
Non le parve un tradimento consolare il Dottore. Era parte della famiglia. E la famiglia si stava sgretolando sotto i suoi occhi. Doveva tenerla unita. Senza tante chiacchiere, senza tante spiegazioni. Contano i fatti, non le parole.
Già molte volte in passato il Dottore l’aveva abbracciata, tenuta stretta per la vita, palpata, quando la Signora non vedeva. Antonietta lasciava fare, dura, in silenzio, come fosse parte dei suoi doveri domestici. Gli era affezionata, gli era grata. Anche quello era un modo di mostrare la sua devozione. E poi, meglio lei che qualche estranea. Lasciava fare, anche per la Signora.
Lei, che aveva solo la terza elementare, cominciò a controllare tutte le ricette, serviva i clienti, stava alla cassa. Alla presenza del Dottore, si capisce, ma il Dottore si limitava a conversare amabilmente con i clienti e faceva cenni d’assenso quando Antonietta, per salvare la forma, gli mostrava le ricette e le scatolette dei medicinali.
Cominciò a tenere i rapporti con i rappresentanti di medicinali, con i fornitori, a tenere in ordine i conti, a gestire il denaro di casa. Da sola mandò avanti la farmacia quando la Signora dovette essere ricoverata in oncologia perché un cancro le stava divorando l’utero sterile. Ablazione totale, le disse il Dottore.
<<Non c’è più niente da fare Antonietta>>, le disse il Dottore finendo di scolare la mezza bottiglia di Curvoisier che aveva accanto. Il viso era livido, tirato, la pelle ingiallita, i tratti come crollati sotto un peso insostenibile. Anche la Signora, come da piccolo sua madre, lo stava abbandonando.
<<No, non deve prenderla così. La Signora è forte, si riprenderà>>, gli disse con dolcezza Antonietta.
<<Sta morendo. Le resta poco da vivere. Le metastasi sono ovunque. Possiamo solo tenere a bada i dolori con la morfina.>>
<<Non so che sono le metastasi, ma dobbiamo avere speranza.>>
<<Speranza? L’ho resa infelice tutta la vita, l’ho tradita, non le ho dato figli. E lei, come una santa, ha sopportato tutto.>>
<<Forse non poteva averne lei, forse è stato un bene>>, cercò di consolarlo. Che vuoi dire a un uomo finito?
Il Dottore guardava nel vuoto. Poi si alzò, si strinse ad Antonietta e la prese lì, sul tappeto del salotto, con la disperazione di chi va a morire. Lo lasciò fare, come si nutre un neonato affamato che s’attacca al seno.
In camera da letto la Signora aveva ricominciato a gridare. I dolori erano insopportabili, devastanti. Antonietta si liberò dall’abbraccio di un corpo quasi inerte e la raggiunse. Le fece l’ennesima iniezione di morfina.
<<Non lo abbandonare>>, sussurrò a fatica la Signora. <<So cosa fate. Lo so da tanto…tem…>> Non poté finire la frase.
Antonietta assentì con la testa e non disse nulla. Non si mente ai morenti.
Poi le chiuse gli occhi. E per la prima volta, da quando era nata, pianse.
Nel testamento la Signora, a cui era intestata la casa e che risultava proprietaria di tutti gli oggetti di valore che conteneva, dei titoli e delle azioni, lasciò erede universale la nipote, con diritto di usufrutto al Dottore. Alla morte del Dottore ogni cosa sarebbe andata a lei.
Due anni dopo, al matrimonio, per cui la nipote aveva gridato allo scandalo — <<si sposa la serva!>> aveva detto a tutto il parentado scandalizzato — Antonietta indossava un abito vaporoso, dal tessuto cosparso di fiori d’ogni colore, con una fascia color verde brillante in vita. Glielo aveva regalato il Dottore perché, diceva, ora che la vita gli sfuggiva, la voleva piena di colori. Ridotto a un’ombra dalla cirrosi che se lo stava divorando vivo, la portò sul Lago di Garda, a Verona, a Venezia, tutti luoghi che Antonietta non aveva mai visto. A Venezia alloggiarono al Bauer. Antonietta lasciò fare, perché anche lui aveva diritto a un po’ di felicità. E anche se nemmeno la felicità è sempre bianca, ma in genere sfumata di molti grigi, sempre felicità è.
<<Anche tu adesso devi fare la signora>>, le disse il Dottore.
<<No Dottore, di Signora ce n’è una sola.>>
*
<<Dottore!>> chiamò Antonietta. <<Vieni che è pronto>>, disse, portando in tavola il sartù fumante.
Trascinando i piedi, il Dottore arrivò dallo studio. Si sedette a tavola e Antonietta gli porse la bottiglia del vino perché lo aprisse e, come le aveva spiegato, lo facesse respirare. Quasi fosse una cosa viva, il vino, che, dopo essere stato rinchiuso per tanto tempo in un contenitore di vetro, fermo, zitto e immobile, avesse bisogno di prendere un po’ d’aria, prima di scivolare, gorgogliando, in gola e nello stomaco. Di aria ne vedeva poca. Una sorte proprio triste.
Con la pala d’argento tagliò una fetta di sartù, che gli servì fumante di profumi. Poi ne depose una porzione nel piatto della Signora e infine una bella fetta per sé, e si sedette a tavola.
<<Ah, che profumo di paradiso…>>, disse il Dottore, rompendo la crosticina croccante con la forchetta, che immerse poi nella magica combinazione di quegli ingredienti legati ad arte. <<La Signora sarebbe orgogliosa di te.>>
<<Mi ha imparato a cucinare la Signora>>, osservò Antonietta, fissando con un mezzo sorriso la sedia vuota e il piatto intatto che era fra loro.
<<Insegnato, non imparato>>, osservò il Dottore.
<<Eh sì, hai ragione, ma comunque è sicuro che se c’era mangiava di gusto poveretta.>>
Alla Signora non aveva mai dato del tu. E, fino a un anno prima, nemmeno al Dottore.
Era il terzo anniversario della morte della Signora e, come ogni anno, si ripeteva il rito funebre gastronomico. Tavola delle feste, sartù, fegato alla veneziana, zuppa inglese. I loro piatti preferiti. Gli altri giorni l’apparecchiatura e il menù erano più modesti, perché il Dottore aveva la cirrosi epatica e doveva stare a dieta. Ma, fin dal giorno seguente alla morte della Signora, i posti in tavola erano stati sempre tre. Solo quando la Signora era ancora in vita erano stati due, perché Antonietta mangiava in cucina dopo aver finito di servire e sparecchiare.
La Signora, per cui Antonietta nutriva una grande venerazione silenziosa, non se n’era mai andata. Nemmeno dal letto matrimoniale che Antonietta divideva con il Dottore, ormai legalmente da un anno, dopo le seconde nozze del vedovo. Di fronte, sul comò, c’era la foto del Dottore e della Signora quando si erano sposati.
Ogni sera, prima di entrare nel letto coniugale, Antonietta si faceva il segno della croce e recitava un ‘Eterno riposo’ per lei.
Il racconto è stato pubblicato all’interno dell’antologia Io sono il Nordest, 2016, Apogeo Editore e farà parte di una nuova edizione dei miei racconti, Fiabe d’amor crudele.

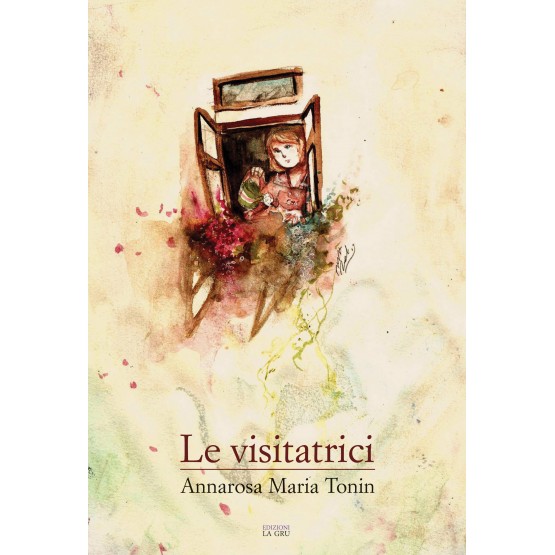
:focal(500x306:501x307)/https://public-media.smithsonianmag.com/filer/30/d3/30d3ad96-9d1d-4b83-84d2-658ea2588f50/maya-angelou-npg-white-border.jpg)

Commenti recenti