
Ospito molto volentieri questo bellissimo testo di Flavio Villani perché lo trovo in grande consonanza con il mio Minotauro e il mio Dedalo. Si scoprono a volte incredibili riverberi della propria visione del mondo in persone a noi sconosciute e così è avvenuto per Villani.
Non solo il soggetto dei testi ci affratella, ma una visione non convenzionale del mito. Una ricerca che, in questo suo Labirinto, è quella di chi si pone da una prospettiva laterale e obliqua.
Ringrazio dunque Flavio Villani per avermi dato l’opportunità di condividere questo suo lavoro.
Francesca Diano
LA NASCITA DEL LABIRINTO
Al destino piacciono le ripetizioni,
le varianti, le simmetrie.
…fosse almeno
questo l’ultimo giorno dell’attesa.
(J.L. Borges)
Infelice fu Asterione, corpo di uomo
testa di toro, nato recluso nella casa
dalle incalcolabili stanze, che nessuna
difesa oppose a Teseo, quando il bronzo
gli affondò in petto, e il ribollente sangue,
come fiume impazzito, sgorgò
impetuoso oltre i labili argini della sua
triste esistenza – sei tu il mio redentore?
domandò speranzoso, fissando
con amorevole occhio la spada
sfolgorante nel sole,
e rapido il sangue colava, nero,
lungo corridoi smisurati, circolari,
oltre non enumerabili porte,
oltre incerte scale e cieche stanze,
e ancora oltre ogni possibile sogno,
a misura di ciò che non è
conoscibile all’uomo: il labirinto.
Costruì Minosse il labirinto per punire
di Pasifae l’impura foia. Volle il Re
vendicare l’insostenibile sdegno per come
fu la sposa sua montata come vacca
sul finire della grande festa, di Creta la festa
mobile, dal Toro più sacro a Poseidone,
la cui scarsa vista fu ingannata
dal sarcofago che Dedalo, l’architetto,
ideò, e con destra mano di carpentiere
intagliò nel duro, duro legno e nero.
Quando Pasifae, la regina, trascinarono
al suo cospetto, nuda, egli la guardò
con gli occhi limpidi dell’ira
e disse, afferrandola per la lunga
chioma fiammeggiante – come?
Come hai potuto farlo? Qui, fra queste
danze, senza pudore, nel mio regno
in terra, fra questa gente che beata
nell’ebbrezza dei misteri,
ha visto te, Pasifae, di Minosse la sposa,
carponi, farti montare e godere
senza vergogna della bestia il potere.
Come hai potuto infamare il mio nome,
sottomettere il tuo corpo alla Bestia,
da lei farti inondare del suo seme? E
gridare, gridare al mondo il tuo deforme
Amore.
Allora, Pasifae, il collo ritorto all’indietro,
in ginocchio, sorridendo, dal basso
lo sguardo rivolse al suo Re, e disse –
In un involucro di legno,
in forma e simulacro di giovenca, nera,
mi rinchiusi solo per farmi amare
di quell’amore che tu, grande Re di Creta,
di notte in notte ti dimentichi
di donare alla tua sposa.
E ora te la grido in faccia la mia
felicità. Sono felice con il mostruoso
frutto in grembo di questo mio amore,
di questo incontenibile, orripilante
amore, che Tu, Immortale
fra gli Immortali, neppure vaga-
mente puoi concepire, e chiami
con così facile parola, mostruoso.
Io,
al contrario, concepisco
un mostro, ma non me ne pento.
Non mi pento dell’amore che ho
goduto, del languore nel mio
ventre in fiamme, della verga del bianco
Toro che mi penetra, del seme che riempie
il mio grembo che Tu, sovrano di un regno
ebbro, giudichi tanto indecente.
Massima ignominia richiama pure
su di me. Ma Io vedo, finalmente. Ora
ti vedo per come davvero sei.
Minosse, prima di cacciarla dal suo sguardo
per sempre, decretò – Sia data casa all’essere
mostruoso che già vive in grembo
alla mia sposa. E che da tale casa
non possa mai più uscire. Un solo ingresso
vi sia di accesso lungo il perimetro,
e una via, una via soltanto conduca per
smisurati giri al centro. Scale e porte
si susseguano senza fine, e così le stanze,
ma che il centro sia irraggiungibile,
e il percorso della via, senza un ritorno,
significhi per chi, sventurato, la percorra,
Morte.
Dedalo, l’infame, il falegname,
l’assassino dell’abile nipote, ne sia
l’artefice, e possa egli morirvi, e con lui
la sua progenie.
Si chiuda la porta alle sue spalle
e il labirinto sia la perpetua sua prigione.
Sappi, Pasifae, che il frutto ignobile
del tuo seno, mezzo uomo e mezzo toro,
si aggirerà triste e famelico per quella casa,
nell’attesa, di anno in anno, che Io,
Minosse, Re di Creta, il più Potente
fra i Potenti, l’Immortale fra gli Immortali,
gli permetta, benevolmente, di vivere.
Che la carne di giovanetti, sette fanciulli
e sette fanciulle, gli sia di nutrimento,
ogni nove anni per tutti i secoli dei secoli.
All’orizzonte la lenta – incessante –
risacca di nuvole,
quando Minosse tacque,
si colorò di sangue.
Il Re, allora, si allontanò, incurvato,
vecchio all’improvviso, vecchio sotto
il peso dei secoli dei secoli, e dei secoli
ancora a venire, e di tutti i secoli che
Egli stesso aveva, imprudente, evocato.
E all’improvviso, come lampo
nello specchio, vide il destino
riflettersi nei suoi occhi stanchi.
Quando Dedalo fu con Icaro
nel labirinto rinchiuso,
provò a ricordare
la spiaggia deserta e il silenzio
e l’immenso mare ma
ogni vista gli fu preclusa dall’alto muro.
Solo, sul capo, l’infinito curvilineo cielo.
Allora Dedalo sollevò il suo sguardo
verso la volta senza risposte, e disse – ogni via
di fuga mi è preclusa, sia essa la nera
Terra o l’instancabile oscuro mare. Solo il cielo
di cristallo, con i suoi cerchi e gli astri
innumerevoli, è libero per ogni fuga.
– Innalzi l’uomo le sue guglie al cielo!
Un’invincibile forza ci trattiene al suolo.
E’ una lotta di due opposte forze, uguali
e contrarie – Dovrò rotolarmi nel fango
come maiale perché possa sperare nel Vero?
Ma è scritto che qualcosa accadrà:
Cresceranno penne sul dorso mio
e di Icaro, mio figlio. Cresceranno, poco a poco,
si formeranno ali, ben strutturate, capaci di
volare, in alto, nel cielo di fuoco.
Nulla sarà più come tale, da lassù vedrò
la Via, distesa, circolare, infinita, il labirinto,
che disegnai per me stesso ma che non conosco;
tutto mi sarà chiaro, nell’aria fulgida del mattino.
Così fu il tempo della fuga: le ali erano
cresciute sotto i curiosi occhi del giovinetto
Icaro – Una volontà sconfinata, disse
Dedalo al figlio, una volontà sconfinata
ha fatto sì che queste ali si conformassero,
perfette per il volo, sul nostro dorso.
Padre e figlio si guardarono,
negli occhi si guardarono per un istante, poi,
tenendosi per mano si avviarono sull’orlo
dell’abisso. Su quella vertigine le ali aprirono
al vento e leggeri, leggeri si librarono in aria.
Liberi,
senza più timore, osservarono dall’alto
ogni cosa farsi piccina. Dimenticarono
presto
la scabra terra, il fango e il deserto pietroso,
la polvere color dell’ocra, sollevata in gelidi
vortici dai venti dell’ostile settentrione, e l’odio,
l’odio di Minosse per Asterione;
E il mare giudicarono una sola massa senza
forma, in movimento continuo, d’argento.
Il sole è così vicino – urlò allora Icaro
contro il rombo del vento,
e, liberata la morbida mano da quella greve
del padre, ascese nella stratosfera sottile.
– Lì il sole è incandescente! Torna da me!
lo scongiurò Dedalo, mentre le ali piumate
le fiamme avvolsero rapide. Icaro cadde,
lento, avvitandosi
in una spirale di fuoco e fumo nero. Senza
un lamento, il sognatore, nel muto mare precipitò.
Ma nulla si fermò in quell’istante: il fulgore
della stagione, lo sbocciare dei teneri germogli,
il contadino che il campo ara in riva al mare.
Trascurabile infatti fu d’Icaro il tonfo.
Dedalo, solo, guardò in basso l’acqua livida
richiudersi come larga tomba, sul corpo pallido e nudo,
mentre l’aria leggera d’improvviso si fece di piombo.
Allora Dedalo disse – a quale dio posso ora
appellarmi? Quale dio avrà pietà di quel vecchio
che spierà l’amore dei giovani?
Al labirinto sono sfuggito, ma ora so che è
pietosa menzogna, insensato abbaglio!
Con questo grido in gola Dedalo continuò
il suo volo, verso l’orizzonte, verso i neri profili
dei monti, verso la profonda tenebra silenziosa.
Appena sopra, solitaria e luminosa, proprio
allora iniziò a brillare, Venere – la prima stella.
………………………………………………
E’ detto:
Il labirinto presiede sui vivi!
Miserevole
l’Essere dal corpo deforme,
cuore di uomo.
Attende dolente,
nella casa dalle innumerabili porte,
l’ombra sfuggente del dio
nel freddo abbaglio del sole.
Quando il tempo sarà finalmente,
che al cielo sollevi le braccia
in segno di devozione sincera.
Lo scruterà – Lui – sbalordito,
ma poi, con mano tremante,
senza pietose parole,
il bronzo gli pianterà al centro del cuore.
(C) by Flavio Villani 2012 RIPRODUZIONE RISERVATA
NOTA BIOGRAFICA
Flavio Villani è nato a Milano nel 1962. Laureato in medicina, è specialista in neurologia.
Dopo tre anni (1989-1992) di lavoro negli Stati Uniti come ricercatore, è rientrato a Milano dove tuttora risiede e lavora.
Parallelamente all’attività professionale, diversi anni fa ha intrapreso un proprio percorso letterario.
In ambito poetico ha pubblicato la raccolta Gli assedi del nulla (Editori della Peste, 2007).
Per il teatro è autore di alcuni atti unici e della tragedia “lirica” in tre atti Il canto di Semmelweis, ispirata al saggio di Ferdinand Céline sulla figura del dottor Semmelweis.





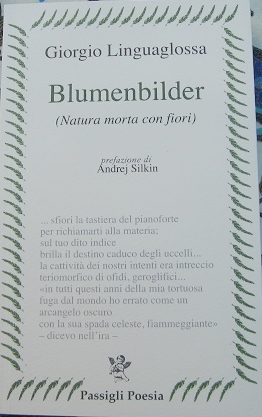







Commenti recenti