
Foto di © Dino Ignani
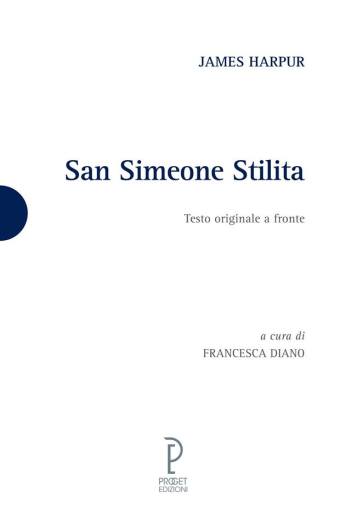
James Harpur San Simeone Stilita, testo a fronte, a cura di Francesca Diano, Proget Edizioni, 2017
In occasione della presenza in Italia di James Harpur, a fine maggio 2017, che ha tenuto, per la prima volta nel nostro paese, una serie di incontri e conferenze, esce l’elegante plaquette con il lungo poemetto in quattro parti San Simeone Stilita, edito da Proget Edizioni e da me curato. Insieme a questo testo, sto lavorando alla ricca antologia Il vento e la creta – selected poems, 1993 – 2016, che raccoglie testi scelti dalle otto raccolte fino ad ora pubblicate e alcuni testi in prosa. James Harpur, un poeta ormai considerato fra i maggiori del nostro tempo a livello internazionale, ma che, in Italia, non ha ancora la fama che merita.
Il poemetto di circa 600 versi, è dedicato alla bizzarra, affascinante figura di San Simeone Stilita. Ne propongo qui la prima parte, con un breve estratto del mio testo introduttivo.
F.D.
***************
“La via in su e la via in giù sono una e la medesima”[1]. E veramente il basamento della colonna da cui clama lo Stilita di James Harpur potrebbe recare incise le parole di Eraclito, poiché quella colonna, che vorrebbe essere una verticale via di fuga dal mondo, ma si rivela vano, illusorio abbaglio, non è vettore unidirezionale verso l’invisibile – ascesa dall’umano al divino, dalla materia allo spirito – ma percorso inverso, anche, dal divino all’umano, ed è, allo stesso tempo, via orizzontale ché, nella tensione che tra quelle polarità si crea, vibra, e questa vibrazione ne dissolve i contorni, fino a sfarli in un alone luminescente. Una vibrazione che si dilata, in onde centrifughe, ad abbracciare lo spazio circostante, permeandolo, inglobandolo.
Fu questa, forse, l’origine dell’attrazione magnetica che colonna e Stilita, non separabile binomio, esercitarono allora, seguitarono ad esercitare dopo la sua morte, ed esercitano, se la sua particolare forma di fuga dal mondo ebbe più di un centinaio di imitatori, ancora fino a metà del XIX secolo, mentre Alfred Tennyson scrisse un poemetto di duecento versi – in realtà assai critico e ironico – sull’anacoreta e Luis Buñuel, nel 1964, girò un film, Simòn del desierto, Leone d’argento alla Mostra del Cinema di Venezia. In entrambi, l’immagine di Simeone è ambigua e contraddittoria; ma questo non deve meravigliare, ché ambiguo e contraddittorio è il rapporto di Simeone con sé stesso, col proprio Dio e con le sue creature.
La colonna, fuga e piedistallo, da lui scelta come distacco-separazione dal mondo e come diretta via d’accesso all’invisibile, è essa stessa contraddizione, anzi, è un paradosso. In fondo non è che un supporto di pochi metri; nulla rispetto all’immensa distanza – non certo solo fisica – fra terra e cielo. Così il Simeone di Harpur anela negando, rifiuta ciò di cui ha sete, cieco di fronte all’essenza stessa di quanto desidera, s’illude di non dover fare i conti col mondo cui appartiene. A tal punto vi appartiene, da sentirsi costretto a operare una rimozione, un’escissione cruenta, di cui parla in termini chirurgici.
Per quanto Simeone si allontani dalla terra, dalla materia che ricusa con tutto l’essere, per quanta distanza ponga tra sé e la realtà, per quanto tenti, accrescendo sempre più l’altezza del suo trampolino, di farsi possessione di Dio oltre un cielo, per lui, deserto quanto il deserto di rocce e sabbia, lo Stilita è prigioniero di un inganno, di un feroce equivoco. E più Simeone nega il suo corpo (parte di quel mondo fisico da cui fugge), più quel corpo esercita una furiosa attrazione sui suoi seguaci. Il suo occhio, che rifiuta di abbracciare la sfera dell’evento per perdersi in quella della forma, se ne stacca e si solleva verso il vuoto, cercando risposta a una domanda improponibile. La crudeltà del suo auto-inganno è tanto più corrosiva, quanto più Simeone trascura l’impossibilità di eliminare uno dei due poli, la tensione dai quali è generata è la vita stessa. Il Simeone di Harpur non vede, se non alla fine, che la sua colonna è inutile; il cielo è qui, Dio è qui, su quella terra che lui si rifiuta di sfiorare, in mezzo a quell’umanità da cui fugge. Inseguito.
Non si dà forma senza evento, né evento senza forma. Non si accede al divino se non passando attraverso l’uomo. Né si accede all’uomo senza fare i conti col Sacro. L’evento primario, per ogni cristiano, è Cristo incarnato. Tu neghi la carne, neghi l’uomo, e neghi Cristo, ne fai una favoletta. Trascendere è possibile solo a condizione di accettare questa verità, e difatti, in tutto il testo, mai Simeone si rivolge altri che a Dio; solo negli ultimi tre versi, dopo l’avvenuta catarsi, nomina Cristo:
Ciascuno è Cristo
Che solo cammina fra campi di grano
O lungo il mare della Galilea.
Solo. La visione che Simeone ha dell’uomo è finalmente quella di Cristo. Solo, ma non separato. Cristo è nella relazione che dell’umanità fa una. È quella relazione. Simeone lo comprende infine quando l’amore di coloro che lo soccorrono e lo riportano in vita, dopo la quasi-morte, cui come giudice spietato si autocondanna, gli rivela da quale profonda tenebra originasse il suo errore, quando, superato il proprio abbaglio, riconosce negli altri, e dunque in sé, il miracolo, sì abbagliante, dell’incarnazione. Abbandonare l’umano per tornare all’umano, dunque.
La via in su e la via in giù sono una e la medesima. Dio, o il Sacro, come lo si intraveda, se mai lo si intravede, non è tenebra, ma è attraversando la tenebra di sé stessi che, nel cercarlo, solamente lo si può trovare, per attitudine o illuminazione. Non è fuori di noi, è in noi.
La piattaforma su cui Simeone visse era di forma quadrata (“la quadrata materia”); il simbolismo numerologico del Quattro, sia come manifestazione di tutto ciò che è concreto e immutabile, sia come manifestazione della materia, dell’ordine, dell’orientamento, torna in tutto il poemetto, a partire dalla sua stessa struttura quadripartita. A significare che la salvezza è in questo mondo, in questa realtà, nell’abbracciare la propria umanità.
[…….] Storicamente, quel corpo che lui aveva negato, dopo la morte scatenò aspre rivalità – vere guerre fra gruppi armati – per il suo possesso. Così, l’originaria negazione del corpo, ne sancisce infine, con ironico rovesciamento, la sacralità, ne fa oggetto di venerazione, facendo del cadavere centro di culto straordinario.
Il corpo fu trasportato ad Antiochia ed esposto per trenta giorni nella chiesa di Cassiano e, successivamente, traslato nel duomo ottagonale costruito da Costantino. L’ottagono, non si dimentichi, è simbolo di resurrezione. Non è chiaro, dai testi, se il corpo o parte di esso, fosse poi portato a Costantinopoli. Nel VII secolo però, con la caduta di Antiochia in mani arabe, di quel corpo si perse ogni traccia.
Quel che invece rimase, come sede di culto vivissimo, fu il luogo ove sorgeva la sua colonna, a Telanissos (ora Qalat Siman, nell’attuale Turchia), e dove sorse un enorme monastero e una grande basilica, di cui oggi restano rovine. Notizie, chiaramente gonfiate ad arte, riportano che la chiesa potesse contenere fino a diecimila persone. Numero che semplicemente indica una grande pluralità indefinita, (penso all’uso di tale numero nella tradizione letteraria e filosofica cinese) ma attesta l’eccezionalità del culto.
[…..]
Francesca Diano
[1] Eraclito, I frammenti e le testimonianze, a cura di Carlo Diano. Fondazione Lorenzo Valla.

Foto di © Dino Ignani
Da
SAN SIMEONE STILITA
Traduzione di Francesca Diano
“Si collocò su di una serie di colonne dove trascorse il resto
della vita. La prima era alta poco meno di tre metri e su
di essa visse quattro anni. La seconda era alta circa cinque
metri e mezzo (tre anni). La terza, di dieci metri, fu la sua casa
per dieci anni, mentre la quarta ed ultima… era alta diciotto
metri. Lì visse per gli ultimi vent’anni della sua vita.”
Oxford Dictionary of the Saints
“Non c’è bisogno di graticole; l’inferno sono gli altri.”
Jean-Paul Sartre
“Ovunque io voli è Inferno; io stesso sono Inferno…”
Milton, Paradiso perduto, IV, 75.
1
Nell’urto del calore,
Tremano gli orizzonti di chiarità fumosa.
Il deserto è un fondale marino
Da cui tutta l’acqua sia riarsa.
Qui non ebbe potenza la creazione
Se non per sabbia, rocce,
Ciuffi d’erba e pidocchi.
Un arco di montagne, vetrose di calore,
Isola questo paradiso adamantino
Dalla profanazione del triviale.
Ho tutto il giorno per volgermi
In direzione dei punti cardinali
In armonia col sole
Osservare il vuoto che m’assedia,
Sabbia che avanza e mai sembra muoversi,
L’armata del non-essere
Che con la notte si dilegua nel nulla.
Sono il centro di un cosmo
Acceso solamente dai miei occhi.
Sono la meridiana del Signore:
La mia ombra è il tempo
Ch’egli proietta dall’eternità.
La notte facevo questo sogno:
Mi trovo a scavare in un deserto
Come scorpione in fuga dal calore;
la buca si fa così ampia e profonda
Che sono chiuso, come in un pozzo,
E sfiorato da un’ombra rinfrescante.
Ogni vangata di sabbia a espellere un peccato
Alleggerisce l’anima dall’oppressione
E illumina il mio corpo dall’interno
Ma mi fa scorgere più buio giù nel fondo
E seguito a scavare
Finché mi sveglio, colgo la luce del giorno.
Con il tempo compresi
Che questo era un sogno capovolto:
Avevo costruito un buco speculare
Ma fatto materiale da blocchi di pietra.
Qui, sulla cima, son mio proprio signore,
Il mio palazzo è una piattaforma balaustrata
Il tetto un baldacchino di sconfinato azzurro,
I terreni di caccia sono un mare di polvere.
Non odo altra voce che la mia,
A profferire anatemi, preghiere – pur solo
Per ricordare il suono,
O mi sussurra in testa, dove evoco
I chiacchierii di Antiochia
Gerusalemme e Damasco,
Di eremiti che ciarlano sui monti.
Signore, è eresia pensare
Che l’isolarsi spiani la via verso di te,
Che la gente sia corrotta ed infetta
Poiché calpesta quiete, silenzio, solitudine
Nel suo accapigliarsi per dar sollievo
Ai tormenti dell’imperfezione?
Quando alla terra ero vincolato, un penitente
Incatenato a una cornice di roccia
Non riuscivo a pregare se non pregando
Che la notte si potesse protrarre
Contro l’onda dell’alba che s’infrangeva
Contro la roccia, rivelando pastorelli
Sboccati, che scagliavano pietre,
E plebaglia di pellegrini
Che passavano da un oracolo all’altro
Condotti senza posa da domande
Lasciate prive di risposta
Per dare un senso alla vita
E far fare esercizio alle gambe.
Perdonami Signore –
Credo di odiare il mio vicino.
Pur se appartengo al mondo
Ora almeno la superficie non la tocco.
So che odio me stesso,
Della vita temo le dita che contaminano,
Pavento gli effluvi del giorno
Sguscianti attraverso sensi incontrollati
Per putrefarsi dentro la mia testa;
Con codardia crescente
Temo l’attaccamento dell’amore
Temo l’infinità della morte
Temo il sonno, l’oscurità, i dèmoni
Striscianti, i loro occhi grigi come pietra.
Lo so che devo rendere me stesso
Un deserto, un vaso ben lustrato,
Perché in me tu riversi il tuo amore
E trasformi in luce la mia carne.
La notte invece sogni immondi
Mi colmano di donne che conobbi –
Ma un po’ mutate e nude –
Che danzando tra velami di sonno
Sussurrano alla mia verginità.
Si dice che simile attrae simile.
Quanto putrido devo essere dentro
Se di continuo mi pasco
D’ira, lussuria, rancori del passato
Rievocando in crudele dettaglio
Involontarie offese che punsero il mio orgoglio,
Lasciando che la vendetta cresca
Con una tale grottesca intensità
Che la bile potrebbe intossicare l’esercito persiano.
Quasi sempre mi sento dilaniato.
Uno spirito che anela alla luce,
E un corpo con colpevoli appetiti
Che domo stando rigido e ritto tutto il giorno,
Osservando la sagoma emaciata
Ruotarmi lenta intorno
In attesa di debolezza, esitazione.
Oppongo la volontà contro la carne
Ma quando il sole viene inghiottito
Mi unisco al buio, ombra mi faccio
Nell’anarchia sudicia dei sogni;
Inerme, alla deriva, tutta notte mi volvo
Attorno alla rammemorante colonna dei miei peccati.
All’alba mi risveglio, avido di provare la letizia
Di Noè che libero galleggia verso
Un mondo incontaminato risplendente,
Ma quando il sole irrompe
Sono un corvo malconcio in un nido
Di sabbia, capelli, feci albe
E croste di pane che un monaco babbeo
Mi lancia insieme a otri –
Un essere senz’ali che sogna di volare
Sento il deserto che mi stipa dentro
Ogni solitudine io abbia mai provato.
Le distese di nulla del deserto
Specchi giganti dell’anima mia
Riflettono ogni frammento di peccato;
Più mi purifico
Più emergono macchie brulicando
Come formiche che schiaccio adirato –
Come può Dio amare la mia carne rattrappita,
La mia fragilità, l’assenza di costanza?
Perché attende per annientarmi?
Mille volte mi inchino ogni giorno –
La notte resto desto a pregare
E prego per star desto.
A volte mi domando s’io preghi
Per tenere il Signore a distanza.
ST SYMEON STYLITES
by
JAMES HARPUR
From
The Dark Age
2007
“He set himself up on a series of pillars where
he spent the remainder of his life. The first one
was about nine feet high, where he lived for four years.
The second was eighteen feet high (three years).
The third, thirty-three feet high, was his home for
ten years, while the fourth and last … was sixty feet
high. Here he lived for the last twenty years of his life.”
OXFORD DICTIONARY OF SAINTS
“No need of a gridiron. Hell it’s other people.”
JEAN-PAUL SARTRE
“Which way I fly is Hell; my self is Hell…”
MILTON, PARADISE LOST, IV.75
1
Heat struck,
Horizons wobble with clarified smoke.
The desert is a sea-bed
From which all water has been burnt.
Creation, here, was impotent
Except in sand, rock,
Spikes of grass, and head lice.
A sweep of mountains, heat glazed,
Cuts off this adamantine paradise
From profanities of the vulgar.
I have all day to turn
Towards the compass points
In rhythm with the sun
And watch the emptiness besiege me,
Advancing sand that never seems to move,
An army of nothingness
Melting away to nothing with the night.
I am the centre of a cosmos
Lit only by my eyes.
I am the sundial of the Lord:
My shadow is the time
He casts from eternity.
I used to have this dream at night:
I’m in a desert digging
Like a scorpion escaping heat;
The hole becomes so wide and deep
That I’m enclosed, as if inside a well,
And lightly touched by cooling shade.
Each spade of sand expels a sin
Relieves the pressure on my soul
And lights my body from within
But makes me see more dark below.
And so I keep on digging
Until I wake and grasp the light of day.
In time I came to realize
The dream was upside-down:
I built a mirror hole
But made material with blocks of stone.
Here, on top, I rule myself,
My palace a balustraded stage
Its roof a canopy of endless blue,
My hunting grounds a sea of dust.
I hear no voice except my own,
Exclaiming curses, prayers – if only
To remind itself of sound,
Or whispering in my head, where I revive
The chatterings of Antioch
Damascus and Jerusalem,
Of hermits gossiping in mountains.
Lord, is it heresy to think
That isolation smoothes the path to you,
That people are infectiously corrupt
Trampling silence, stillness, solitude
In their scramble to relieve
The agony of imperfection?
When I was earthbound, a penitent
Chained up on a mountain ledge
I could not pray except to pray
For night to be protracted
Against the wave of dawn that broke
Against the rock, unveiling shepherds boys
Foul-mouthed, throwing stones,
And ragtag pilgrims
Drifting from oracle to oracle
Led on and on by questions
They kept unanswered
To give their lives a meaning
Their legs some exercise.
Forgive me Lord –
I think I hate my neighbour.
I may be of the world
But now at least I do not touch its surface.
I know I hate myself,
Fearful of life’s contaminating fingers,
Dreading the day’s effluvia
That slip through each unguarded sense
To rot inside my head;
More and more I’m cowardly
Afraid of love’s attachments
Afraid of death’s infinity
Afraid of sleep, darkness, demons
Scuttling, their eyes as grey as stone.
I know I have to make myself
Into a desert, a vessel scoured,
For you to pour your love in me
And turn my flesh to light.
Instead at night foul dreams
Fill me with women I once knew –
But slightly rearranged and naked –
Who dance through veils of sleep
Whispering to my virginity.
It’s said that like draws like.
How putrid I must be inside
That I’m forever feasting on
Anger, lust, spite from years ago
Recalling in excruciating detail
Unwitting slights that pricked my pride,
And letting vengeance grow
With such grotesque intensity
The bile would poison all the Persian army.
Most days I think I’m split in two.
A spirit yearning for the light
And a body of delinquent appetites
I tame by standing stiff all day,
Watching its scraggy silhouette
Revolve around me slowly
Waiting for hesitation, weakness.
I set my will against my flesh
But when the sun is swallowed up
I join the dark, become a shade
Within the filthy anarchy of dreams;
Helpless, adrift, I’m turned nightlong
Around the memory column of my sins.
At dawn I wake, bursting to feel the joy
Of Noah floating free towards
A shining uncontaminated world.
But when the sun erupts
I am a tatty raven in a nest
Of sand, hair, albino faeces
And bread rinds a half-wit monk
Lobs up to me with water-skins –
A wingless creature dreaming of flight
Feeling the desert cram inside me
Every loneliness I’ve ever known.
The desert’s fields of nothing
Are giant mirrors of my soul
Reflecting every scrap of sin;
The more I purge myself
The more the specks crawl out
Like ants I stamp to death in rage –
How can God love my shrinking flesh,
My frailty, lack of constancy?
Why does he wait to strike me down?
I bow a thousand times a day –
At night I stay awake to pray
And pray to stay awake.
Sometimes I wonder if I pray
To keep the Lord away?
© by James Harpur, 2007 e Francesca Diano 2017. RIPRODUZIONE RISERVATA


Commenti recenti