
La trovate qui
http://ilpostodelleparole.typepad.com/blog/2015/09/francesca-diano.html
28 Ago 2018 Lascia un commento
in Francesca Diano traduttrice, James Harpur, Libro di Kells, Uncategorized Tag:Francesca Diano, James Harpur, Libro di Kells, poesia irlandese contemporanea, poeti irlandesi
28 Mag 2017 Lascia un commento
in Francesca Diano, Francesca Diano traduttrice, Irish poetry, Irlanda, James Harpur, poesia irlandese contemporanea, poeti irlandesi, Uncategorized Tag:Francesca Diano, Francesca Diano traduttrice, James Harpur, poeti irlandesi, Proget Edizioni, San Simeone Stilita

Foto di © Dino Ignani
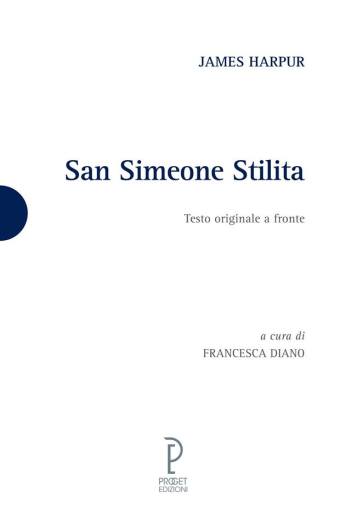
James Harpur San Simeone Stilita, testo a fronte, a cura di Francesca Diano, Proget Edizioni, 2017
In occasione della presenza in Italia di James Harpur, a fine maggio 2017, che ha tenuto, per la prima volta nel nostro paese, una serie di incontri e conferenze, esce l’elegante plaquette con il lungo poemetto in quattro parti San Simeone Stilita, edito da Proget Edizioni e da me curato. Insieme a questo testo, sto lavorando alla ricca antologia Il vento e la creta – selected poems, 1993 – 2016, che raccoglie testi scelti dalle otto raccolte fino ad ora pubblicate e alcuni testi in prosa. James Harpur, un poeta ormai considerato fra i maggiori del nostro tempo a livello internazionale, ma che, in Italia, non ha ancora la fama che merita.
Il poemetto di circa 600 versi, è dedicato alla bizzarra, affascinante figura di San Simeone Stilita. Ne propongo qui la prima parte, con un breve estratto del mio testo introduttivo.
F.D.
***************
“La via in su e la via in giù sono una e la medesima”[1]. E veramente il basamento della colonna da cui clama lo Stilita di James Harpur potrebbe recare incise le parole di Eraclito, poiché quella colonna, che vorrebbe essere una verticale via di fuga dal mondo, ma si rivela vano, illusorio abbaglio, non è vettore unidirezionale verso l’invisibile – ascesa dall’umano al divino, dalla materia allo spirito – ma percorso inverso, anche, dal divino all’umano, ed è, allo stesso tempo, via orizzontale ché, nella tensione che tra quelle polarità si crea, vibra, e questa vibrazione ne dissolve i contorni, fino a sfarli in un alone luminescente. Una vibrazione che si dilata, in onde centrifughe, ad abbracciare lo spazio circostante, permeandolo, inglobandolo.
Fu questa, forse, l’origine dell’attrazione magnetica che colonna e Stilita, non separabile binomio, esercitarono allora, seguitarono ad esercitare dopo la sua morte, ed esercitano, se la sua particolare forma di fuga dal mondo ebbe più di un centinaio di imitatori, ancora fino a metà del XIX secolo, mentre Alfred Tennyson scrisse un poemetto di duecento versi – in realtà assai critico e ironico – sull’anacoreta e Luis Buñuel, nel 1964, girò un film, Simòn del desierto, Leone d’argento alla Mostra del Cinema di Venezia. In entrambi, l’immagine di Simeone è ambigua e contraddittoria; ma questo non deve meravigliare, ché ambiguo e contraddittorio è il rapporto di Simeone con sé stesso, col proprio Dio e con le sue creature.
La colonna, fuga e piedistallo, da lui scelta come distacco-separazione dal mondo e come diretta via d’accesso all’invisibile, è essa stessa contraddizione, anzi, è un paradosso. In fondo non è che un supporto di pochi metri; nulla rispetto all’immensa distanza – non certo solo fisica – fra terra e cielo. Così il Simeone di Harpur anela negando, rifiuta ciò di cui ha sete, cieco di fronte all’essenza stessa di quanto desidera, s’illude di non dover fare i conti col mondo cui appartiene. A tal punto vi appartiene, da sentirsi costretto a operare una rimozione, un’escissione cruenta, di cui parla in termini chirurgici.
Per quanto Simeone si allontani dalla terra, dalla materia che ricusa con tutto l’essere, per quanta distanza ponga tra sé e la realtà, per quanto tenti, accrescendo sempre più l’altezza del suo trampolino, di farsi possessione di Dio oltre un cielo, per lui, deserto quanto il deserto di rocce e sabbia, lo Stilita è prigioniero di un inganno, di un feroce equivoco. E più Simeone nega il suo corpo (parte di quel mondo fisico da cui fugge), più quel corpo esercita una furiosa attrazione sui suoi seguaci. Il suo occhio, che rifiuta di abbracciare la sfera dell’evento per perdersi in quella della forma, se ne stacca e si solleva verso il vuoto, cercando risposta a una domanda improponibile. La crudeltà del suo auto-inganno è tanto più corrosiva, quanto più Simeone trascura l’impossibilità di eliminare uno dei due poli, la tensione dai quali è generata è la vita stessa. Il Simeone di Harpur non vede, se non alla fine, che la sua colonna è inutile; il cielo è qui, Dio è qui, su quella terra che lui si rifiuta di sfiorare, in mezzo a quell’umanità da cui fugge. Inseguito.
Non si dà forma senza evento, né evento senza forma. Non si accede al divino se non passando attraverso l’uomo. Né si accede all’uomo senza fare i conti col Sacro. L’evento primario, per ogni cristiano, è Cristo incarnato. Tu neghi la carne, neghi l’uomo, e neghi Cristo, ne fai una favoletta. Trascendere è possibile solo a condizione di accettare questa verità, e difatti, in tutto il testo, mai Simeone si rivolge altri che a Dio; solo negli ultimi tre versi, dopo l’avvenuta catarsi, nomina Cristo:
Ciascuno è Cristo
Che solo cammina fra campi di grano
O lungo il mare della Galilea.
Solo. La visione che Simeone ha dell’uomo è finalmente quella di Cristo. Solo, ma non separato. Cristo è nella relazione che dell’umanità fa una. È quella relazione. Simeone lo comprende infine quando l’amore di coloro che lo soccorrono e lo riportano in vita, dopo la quasi-morte, cui come giudice spietato si autocondanna, gli rivela da quale profonda tenebra originasse il suo errore, quando, superato il proprio abbaglio, riconosce negli altri, e dunque in sé, il miracolo, sì abbagliante, dell’incarnazione. Abbandonare l’umano per tornare all’umano, dunque.
La via in su e la via in giù sono una e la medesima. Dio, o il Sacro, come lo si intraveda, se mai lo si intravede, non è tenebra, ma è attraversando la tenebra di sé stessi che, nel cercarlo, solamente lo si può trovare, per attitudine o illuminazione. Non è fuori di noi, è in noi.
La piattaforma su cui Simeone visse era di forma quadrata (“la quadrata materia”); il simbolismo numerologico del Quattro, sia come manifestazione di tutto ciò che è concreto e immutabile, sia come manifestazione della materia, dell’ordine, dell’orientamento, torna in tutto il poemetto, a partire dalla sua stessa struttura quadripartita. A significare che la salvezza è in questo mondo, in questa realtà, nell’abbracciare la propria umanità.
[…….] Storicamente, quel corpo che lui aveva negato, dopo la morte scatenò aspre rivalità – vere guerre fra gruppi armati – per il suo possesso. Così, l’originaria negazione del corpo, ne sancisce infine, con ironico rovesciamento, la sacralità, ne fa oggetto di venerazione, facendo del cadavere centro di culto straordinario.
Il corpo fu trasportato ad Antiochia ed esposto per trenta giorni nella chiesa di Cassiano e, successivamente, traslato nel duomo ottagonale costruito da Costantino. L’ottagono, non si dimentichi, è simbolo di resurrezione. Non è chiaro, dai testi, se il corpo o parte di esso, fosse poi portato a Costantinopoli. Nel VII secolo però, con la caduta di Antiochia in mani arabe, di quel corpo si perse ogni traccia.
Quel che invece rimase, come sede di culto vivissimo, fu il luogo ove sorgeva la sua colonna, a Telanissos (ora Qalat Siman, nell’attuale Turchia), e dove sorse un enorme monastero e una grande basilica, di cui oggi restano rovine. Notizie, chiaramente gonfiate ad arte, riportano che la chiesa potesse contenere fino a diecimila persone. Numero che semplicemente indica una grande pluralità indefinita, (penso all’uso di tale numero nella tradizione letteraria e filosofica cinese) ma attesta l’eccezionalità del culto.
[…..]
Francesca Diano
[1] Eraclito, I frammenti e le testimonianze, a cura di Carlo Diano. Fondazione Lorenzo Valla.

Foto di © Dino Ignani
Da
SAN SIMEONE STILITA
Traduzione di Francesca Diano
“Si collocò su di una serie di colonne dove trascorse il resto
della vita. La prima era alta poco meno di tre metri e su
di essa visse quattro anni. La seconda era alta circa cinque
metri e mezzo (tre anni). La terza, di dieci metri, fu la sua casa
per dieci anni, mentre la quarta ed ultima… era alta diciotto
metri. Lì visse per gli ultimi vent’anni della sua vita.”
Oxford Dictionary of the Saints
“Non c’è bisogno di graticole; l’inferno sono gli altri.”
Jean-Paul Sartre
“Ovunque io voli è Inferno; io stesso sono Inferno…”
Milton, Paradiso perduto, IV, 75.
1
Nell’urto del calore,
Tremano gli orizzonti di chiarità fumosa.
Il deserto è un fondale marino
Da cui tutta l’acqua sia riarsa.
Qui non ebbe potenza la creazione
Se non per sabbia, rocce,
Ciuffi d’erba e pidocchi.
Un arco di montagne, vetrose di calore,
Isola questo paradiso adamantino
Dalla profanazione del triviale.
Ho tutto il giorno per volgermi
In direzione dei punti cardinali
In armonia col sole
Osservare il vuoto che m’assedia,
Sabbia che avanza e mai sembra muoversi,
L’armata del non-essere
Che con la notte si dilegua nel nulla.
Sono il centro di un cosmo
Acceso solamente dai miei occhi.
Sono la meridiana del Signore:
La mia ombra è il tempo
Ch’egli proietta dall’eternità.
La notte facevo questo sogno:
Mi trovo a scavare in un deserto
Come scorpione in fuga dal calore;
la buca si fa così ampia e profonda
Che sono chiuso, come in un pozzo,
E sfiorato da un’ombra rinfrescante.
Ogni vangata di sabbia a espellere un peccato
Alleggerisce l’anima dall’oppressione
E illumina il mio corpo dall’interno
Ma mi fa scorgere più buio giù nel fondo
E seguito a scavare
Finché mi sveglio, colgo la luce del giorno.
Con il tempo compresi
Che questo era un sogno capovolto:
Avevo costruito un buco speculare
Ma fatto materiale da blocchi di pietra.
Qui, sulla cima, son mio proprio signore,
Il mio palazzo è una piattaforma balaustrata
Il tetto un baldacchino di sconfinato azzurro,
I terreni di caccia sono un mare di polvere.
Non odo altra voce che la mia,
A profferire anatemi, preghiere – pur solo
Per ricordare il suono,
O mi sussurra in testa, dove evoco
I chiacchierii di Antiochia
Gerusalemme e Damasco,
Di eremiti che ciarlano sui monti.
Signore, è eresia pensare
Che l’isolarsi spiani la via verso di te,
Che la gente sia corrotta ed infetta
Poiché calpesta quiete, silenzio, solitudine
Nel suo accapigliarsi per dar sollievo
Ai tormenti dell’imperfezione?
Quando alla terra ero vincolato, un penitente
Incatenato a una cornice di roccia
Non riuscivo a pregare se non pregando
Che la notte si potesse protrarre
Contro l’onda dell’alba che s’infrangeva
Contro la roccia, rivelando pastorelli
Sboccati, che scagliavano pietre,
E plebaglia di pellegrini
Che passavano da un oracolo all’altro
Condotti senza posa da domande
Lasciate prive di risposta
Per dare un senso alla vita
E far fare esercizio alle gambe.
Perdonami Signore –
Credo di odiare il mio vicino.
Pur se appartengo al mondo
Ora almeno la superficie non la tocco.
So che odio me stesso,
Della vita temo le dita che contaminano,
Pavento gli effluvi del giorno
Sguscianti attraverso sensi incontrollati
Per putrefarsi dentro la mia testa;
Con codardia crescente
Temo l’attaccamento dell’amore
Temo l’infinità della morte
Temo il sonno, l’oscurità, i dèmoni
Striscianti, i loro occhi grigi come pietra.
Lo so che devo rendere me stesso
Un deserto, un vaso ben lustrato,
Perché in me tu riversi il tuo amore
E trasformi in luce la mia carne.
La notte invece sogni immondi
Mi colmano di donne che conobbi –
Ma un po’ mutate e nude –
Che danzando tra velami di sonno
Sussurrano alla mia verginità.
Si dice che simile attrae simile.
Quanto putrido devo essere dentro
Se di continuo mi pasco
D’ira, lussuria, rancori del passato
Rievocando in crudele dettaglio
Involontarie offese che punsero il mio orgoglio,
Lasciando che la vendetta cresca
Con una tale grottesca intensità
Che la bile potrebbe intossicare l’esercito persiano.
Quasi sempre mi sento dilaniato.
Uno spirito che anela alla luce,
E un corpo con colpevoli appetiti
Che domo stando rigido e ritto tutto il giorno,
Osservando la sagoma emaciata
Ruotarmi lenta intorno
In attesa di debolezza, esitazione.
Oppongo la volontà contro la carne
Ma quando il sole viene inghiottito
Mi unisco al buio, ombra mi faccio
Nell’anarchia sudicia dei sogni;
Inerme, alla deriva, tutta notte mi volvo
Attorno alla rammemorante colonna dei miei peccati.
All’alba mi risveglio, avido di provare la letizia
Di Noè che libero galleggia verso
Un mondo incontaminato risplendente,
Ma quando il sole irrompe
Sono un corvo malconcio in un nido
Di sabbia, capelli, feci albe
E croste di pane che un monaco babbeo
Mi lancia insieme a otri –
Un essere senz’ali che sogna di volare
Sento il deserto che mi stipa dentro
Ogni solitudine io abbia mai provato.
Le distese di nulla del deserto
Specchi giganti dell’anima mia
Riflettono ogni frammento di peccato;
Più mi purifico
Più emergono macchie brulicando
Come formiche che schiaccio adirato –
Come può Dio amare la mia carne rattrappita,
La mia fragilità, l’assenza di costanza?
Perché attende per annientarmi?
Mille volte mi inchino ogni giorno –
La notte resto desto a pregare
E prego per star desto.
A volte mi domando s’io preghi
Per tenere il Signore a distanza.
ST SYMEON STYLITES
by
JAMES HARPUR
From
The Dark Age
2007
“He set himself up on a series of pillars where
he spent the remainder of his life. The first one
was about nine feet high, where he lived for four years.
The second was eighteen feet high (three years).
The third, thirty-three feet high, was his home for
ten years, while the fourth and last … was sixty feet
high. Here he lived for the last twenty years of his life.”
OXFORD DICTIONARY OF SAINTS
“No need of a gridiron. Hell it’s other people.”
JEAN-PAUL SARTRE
“Which way I fly is Hell; my self is Hell…”
MILTON, PARADISE LOST, IV.75
1
Heat struck,
Horizons wobble with clarified smoke.
The desert is a sea-bed
From which all water has been burnt.
Creation, here, was impotent
Except in sand, rock,
Spikes of grass, and head lice.
A sweep of mountains, heat glazed,
Cuts off this adamantine paradise
From profanities of the vulgar.
I have all day to turn
Towards the compass points
In rhythm with the sun
And watch the emptiness besiege me,
Advancing sand that never seems to move,
An army of nothingness
Melting away to nothing with the night.
I am the centre of a cosmos
Lit only by my eyes.
I am the sundial of the Lord:
My shadow is the time
He casts from eternity.
I used to have this dream at night:
I’m in a desert digging
Like a scorpion escaping heat;
The hole becomes so wide and deep
That I’m enclosed, as if inside a well,
And lightly touched by cooling shade.
Each spade of sand expels a sin
Relieves the pressure on my soul
And lights my body from within
But makes me see more dark below.
And so I keep on digging
Until I wake and grasp the light of day.
In time I came to realize
The dream was upside-down:
I built a mirror hole
But made material with blocks of stone.
Here, on top, I rule myself,
My palace a balustraded stage
Its roof a canopy of endless blue,
My hunting grounds a sea of dust.
I hear no voice except my own,
Exclaiming curses, prayers – if only
To remind itself of sound,
Or whispering in my head, where I revive
The chatterings of Antioch
Damascus and Jerusalem,
Of hermits gossiping in mountains.
Lord, is it heresy to think
That isolation smoothes the path to you,
That people are infectiously corrupt
Trampling silence, stillness, solitude
In their scramble to relieve
The agony of imperfection?
When I was earthbound, a penitent
Chained up on a mountain ledge
I could not pray except to pray
For night to be protracted
Against the wave of dawn that broke
Against the rock, unveiling shepherds boys
Foul-mouthed, throwing stones,
And ragtag pilgrims
Drifting from oracle to oracle
Led on and on by questions
They kept unanswered
To give their lives a meaning
Their legs some exercise.
Forgive me Lord –
I think I hate my neighbour.
I may be of the world
But now at least I do not touch its surface.
I know I hate myself,
Fearful of life’s contaminating fingers,
Dreading the day’s effluvia
That slip through each unguarded sense
To rot inside my head;
More and more I’m cowardly
Afraid of love’s attachments
Afraid of death’s infinity
Afraid of sleep, darkness, demons
Scuttling, their eyes as grey as stone.
I know I have to make myself
Into a desert, a vessel scoured,
For you to pour your love in me
And turn my flesh to light.
Instead at night foul dreams
Fill me with women I once knew –
But slightly rearranged and naked –
Who dance through veils of sleep
Whispering to my virginity.
It’s said that like draws like.
How putrid I must be inside
That I’m forever feasting on
Anger, lust, spite from years ago
Recalling in excruciating detail
Unwitting slights that pricked my pride,
And letting vengeance grow
With such grotesque intensity
The bile would poison all the Persian army.
Most days I think I’m split in two.
A spirit yearning for the light
And a body of delinquent appetites
I tame by standing stiff all day,
Watching its scraggy silhouette
Revolve around me slowly
Waiting for hesitation, weakness.
I set my will against my flesh
But when the sun is swallowed up
I join the dark, become a shade
Within the filthy anarchy of dreams;
Helpless, adrift, I’m turned nightlong
Around the memory column of my sins.
At dawn I wake, bursting to feel the joy
Of Noah floating free towards
A shining uncontaminated world.
But when the sun erupts
I am a tatty raven in a nest
Of sand, hair, albino faeces
And bread rinds a half-wit monk
Lobs up to me with water-skins –
A wingless creature dreaming of flight
Feeling the desert cram inside me
Every loneliness I’ve ever known.
The desert’s fields of nothing
Are giant mirrors of my soul
Reflecting every scrap of sin;
The more I purge myself
The more the specks crawl out
Like ants I stamp to death in rage –
How can God love my shrinking flesh,
My frailty, lack of constancy?
Why does he wait to strike me down?
I bow a thousand times a day –
At night I stay awake to pray
And pray to stay awake.
Sometimes I wonder if I pray
To keep the Lord away?
© by James Harpur, 2007 e Francesca Diano 2017. RIPRODUZIONE RISERVATA
27 Set 2016 1 Commento
in Francesca Diano traduttrice, James Harpur, poesia irlandese contemporanea, poeti irlandesi, Uncategorized Tag:Anassimene, arte e scienza, fisica quantistica, Francesca Diano, Francesca Diano traduttrice, James Harpur, poeti irlandesi contemporanei
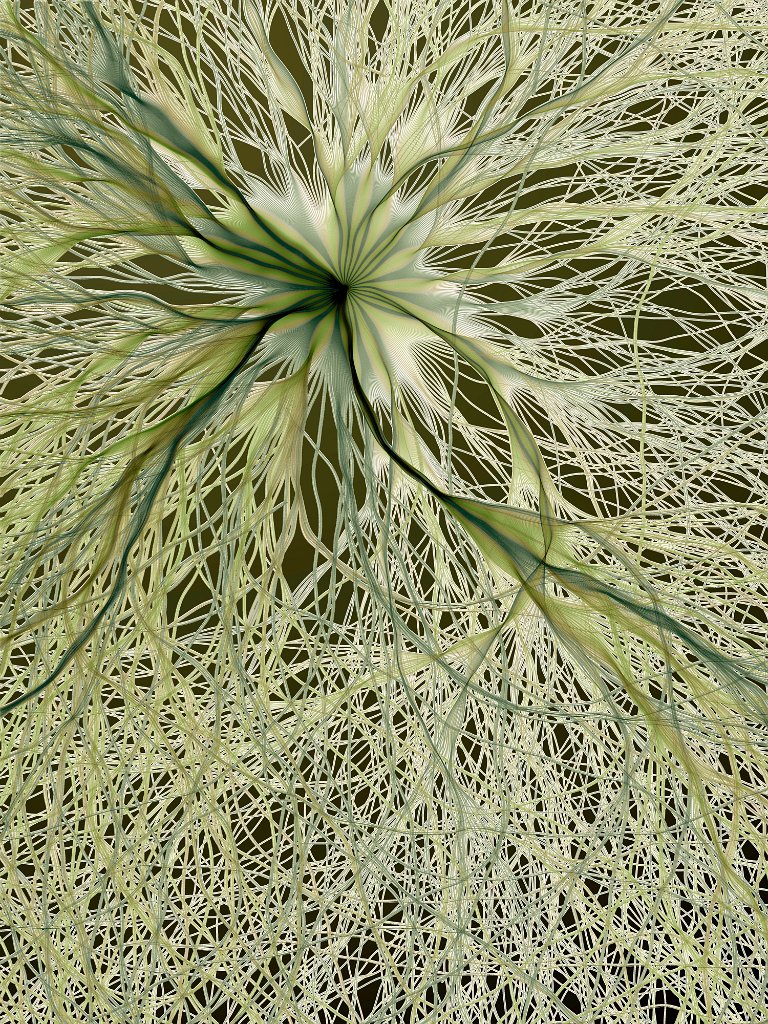
Photo (C) Eric J. Heller.
Questo il sito dello scienziato Eric J. Heller: http://jalbum.net/it/browse/user/album/1696720
La foto dello scienziato Eric J. Heller, valente studioso di fisica quantistica, quanto visionario artista , Transport XIXB, visualizza lo studio di un particolare momento del flusso di elettroni gassosi. Questa serie è stata ispirata dagli esperimenti di Mark Topinka, Brian Leroy, e Professor Robert Westervelt ad Harvard per i quali Eric Heller e Scot Shaw hanno lavorato alla componente teorica. L’ho trovata meravigliosamente adatta a illustrare lo splendido testo di Harpur, perché è come se la scienza ai suoi albori, che si fondeva con la filosofia e la poesia, si potesse riconoscere nei suoi più recenti sviluppi, quando, come in questo caso, la scienza è arte essa stessa. Nel leggere il testo di Harpur, che non è ispirato, si badi bene, a questa immagine, sono rimasta profondamente colpita da come i suoi versi sembrino invece descriverla e commentarla. Descrivere cioè, con il linguaggio quasi mistico della sua coltissima poesia, le strutture più profonde e invisibili della materia.
F. D.
Anassimene
L’anima nostra è aria, guarda il respiro
Che entra gelido, riappare
Fantasma che s’arriccia mentre cammini all’alba
Fra boschi di pini che s’estendono
Sulle colline sulla città dormiente.
Come in basso così in alto. Un inverno in cui
Gli arbusti si rattrappirono in nudi agglomerati
Le querce e i faggi, gli sfavillanti salici
Lasciarono la luce scorrere lungo gli spogli rami;
Quando l’erba decrebbe, si sciolsero i cespugli
E la foresta spalancò i suoi sentieri
Come canali che dopo la meditazione si liberano
Quando il sole velato si fermò
All’improvviso ebbi la visione –
Creazione come momento non creato
Lo pneuma è un flusso ininterrotto
Di mobilità infinita e delicatezza
Che assume sempre rinnovate forme,
Una luce che nulla perde di se stessa
Mentre si materializza nel mondo
E si sposta come uno sciame d’api
Per dar forma a nuove particole di senso:
L’aria s’andò addensando in foschia
Poi lentamente s’ingrossò in pioggia
Che creò attrito, cadde a schizzi
Nei solchi e riempì le pozzanghere
Poi più s’addensò in fango e melma
Che il tempo avrebbe indurito come pietra
O per rarefazione ritrasformata in bruma
Per sollevarsi ancora diluendosi in aria
E rarefarsi ancora sempre più –
Raffinandosi e ancora raffinandosi
In oscillanti granuli di fiamma
Fluenti verso l’alto in piccole faville
Per riunirsi in pozze ardenti a risplendere
Dall’emisfero delle tenebre
In forma di stelle e di luna e di sole.
****
Anaximenes
Our souls are air, just watch the breath
That enters icy, reappears
A curling ghost on early morning walks
Through groves of pines that stretch
Along the hills above the sleeping town.
As below, so above. One winter, when
Shrubs shrank in naked tangles
Oaks and beeches, flashing willows
Let light glide through bare branches;
When grass subsided, bushes melted
And the forest opened up its paths
Like channels clearing after meditation
When the shrouded sun stood still
I suddenly saw the vision –
Creation as an uncreated movement
The pneuma in a never-ending stream
Of infinite mobility and tenderness
Assuming ever-fresher forms,
A light that loses nothing from itself
Materializing in the world
And shifting like a swarm of bees
To shape new particles of meaning:
Air was thickening into mist
Then slowly coarsened into rain
Which gathered friction, splashed
In ruts and filled up pools
Grew denser into slush and mud
That time would harden into stone
Or turn by rarefaction back to mist
To rise up thinning into air again
Then growing rarer still –
Refining and refining further
Into flickering grains of flame
Streaming up in sparklings
To coalesce in fiery pools to shine
From the hemisphere of darkness
As stars and moon and sun.
(C) by James Harpur – (per la traduzione Francesca Diano) RIPRODUZIONE RISERVATA
14 Mar 2016 Lascia un commento
in Francesca Diano traduttrice, Neal Hall, poesia, poesia americana contemporanea, poeti americani Tag:Francesca Diano, Neal Hall, poesia americana contemporanea, poeti americani
E’ con grande gioia che condivido una poesia, ancora inedita, che Neal Hall ha scritto solo qualche giorno fa durante il suo soggiorno italiano. E’ una poesia importante, una dichiarazione di poetica, in cui Hall riflette sul valore e sul senso della Forma per l’artista: non una limitazione o una costrizione, ma la via aurea verso la libertà creativa.
Neal Hall, riconosciuto come uno dei maggiori e più originali poeti americani viventi, sarà a Padova il 21 aprile per un incontro pubblico organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.
F.D.
Forma
è questa crisalide –
questo crogiuolo che mette
ali alle farfalle per volare
questa cisterna di fiumi
che schiude mari
la pula da cui le granaglie
macinate vengono liberate
questa cista da cui l’eternità si solleva
la forma è disciplina,
crogiuolo grazie al quale
perdiamo la costrizione della forma
la forma è la via che apre i mari
la via d’uscita dalla crisalide
è la disciplina della forma
quella foggia di bocca
che libera le labbra per baciare
oltre la foggia di labbra e bocca
è il latte del seno
non il seno materno
che ci nutre, ci forma, ci fa liberi
dal seno materno
la forma è la via d’uscita dalla forma,
la ferrovia sotterranea
non la destinazione che libera
l’artista dai binari della via
forma è percorso verso il non formato,
l’essenza dell’essere; il crogiuolo che mette
ali alle farfalle per volare
in mare aperto
Form
it is this chrysalis –
this crucible that sets
wings to butterflies to fly
this cistern of rivers
that opens seas
the chaff from which ground
grist of grain are freed
this cist, eternity lifts itself out of
form is the discipline,
the crucible through which
we lose the constraints of form
form is the way to open seas,
the way out the chrysalis
it is the discipline of form,
that shape of mouth
that frees the lips to kiss
beyond the shape of lips and mouth
it is the breast milk
not the mother’s breast
that feeds us, forms us, frees us from
the mother’s breast
form is the way out of form,
it is the underground railroad
not the destination freeing the
artist from the rails of the road
form is the path to formlessness,
the gist of being; the crucible that sets
wings to butterflies to fly
through opens seas
(C) Neal Hall e Francesca Diano RIPRODUZIONE RISERVATA
21 Mar 2014 6 commenti
in Francesca Diano, Francesca Diano traduttrice, ireland, Irish poems, Irish poetry, Irlanda, James Harpur, Libro di Kells, poesia, poesia irlandese contemporanea, poeti irlandesi, Voices of the Book of Kells
Traduzione di FRANCESCA DIANO
**********
Sono da anni, da quando l’ho scoperto in Irlanda, innamorata della poesia di questo grandissimo poeta, e di suo ho tradotto vari testi. Per la Giornata Mondiale della Poesia ho deciso di rendergli omaggio pubblicando la mia traduzione, in anteprima assoluta per l’Italia, dato che nulla di lui è mai stato da noi tradotto, del suo lungo poemetto sul miracolo di sconvolgente bellezza che è il Libro di Kells. Questa, L’Orafo, è la prima di quattro parti che compongono l’opera.
Harpur è nato nel 1956 da genitori angloirlandesi e da alcuni anni si è trasferito a vivere nella Contea di Cork a Clonakilty. Ha compiuto studi classici, approfondendo soprattutto la storia e la letteratura irlandese ma anche latina e greca dei primi secoli del cristianesimo e ha soggiornato per lunghi periodi sull’isola di Creta, ambiente che ha ispirato molte delle sue opere. La sua è una delle voci più originali, colte e intense della poesia irlandese contemporanea in lingua inglese e, non mi parrebbe eccessivo dire, della poesia europea, non solo per la cultura vastissima, per l’originalità della sua voce, ma per i temi che tratta, che spaziano dall’Irlanda celtica, a quella protocristiana, al declino del mondo classico in occidente, alla contemporaneità. Ha pubblicato varie raccolte di testi poetici con la prestigiosa Anvil Press e una meravigliosa traduzione di Boezio, che ha intitolato Fortune’s Prisoner. Ma traduzioni ha pubblicato anche da Dante, da Virgilio, da Tagore, da Eschilo, da Plotino ecc.
Interessantissimo è l’uso della metrica, che spesso è quella classica; trimetro giambico, distico elegiaco ecc.
Da A Vision of Comets, a The Monk’s Dream, da The Dark Age a Oracle Bones a Voices of the Book of Kells, le sue raccolte poetiche gli hanno guadagnato moltissimi riconoscimenti e premi. Nel 1995 ha ricevuto the British National Poetry Prize, borse dalla Cork Arts, dall’Arts Council, dall’Eric Gregory Trust e dalla Society of Authors. Nel 2009 ha vinto il Michael Hartnett Award. E’ direttore della sezione poesia di Southword, uno dei più importanti e autorevoli periodici letterari irlandesi e del Temenos Academy Review. È stato poeta residente per il Munster Literary Centre e la Cattedrale di Exeter.
La sua è una poesia dalla voce forte e potente, che getta una luce del tutto nuova su un’epoca poco frequentata e sui santi irlandesi dei primi secoli dell’era cristiana, su figure di primi asceti cristiani o di aruspici di Siria e d’Egitto, su figure pagane dell’Irlanda che sta per divenire cristiana, su personaggi, temi e aspetti di diverse tradizioni e culture, ma che tutte appartengono a quei secoli insomma critici e di passaggio dal mondo antico al primo Medio Evo. Ma non mancano temi più personali e intimi, che lo vedono muoversi nell’Irlanda contemporanea. È una poesia fortemente impregnata di misticismo, dunque molto irlandese, ma un misticismo che ha una profondissima connessione con la modernità. Il travaglio del passaggio da un’epoca a un’altra infatti è l’eco del nostro, le domande che torturano i suoi asceti, cristiani e pagani, i dubbi che attanagliano suoi uomini, i suoi indovini, i suoi monaci, sospesi tra un mondo e un altro, sono i nostri, la fine drammatica di un’epoca che si avvia incerta verso l’ignoto è la nostra.
Ho da anni l’onore di un rapporto epistolare con James Harpur, che presento in anteprima assoluta per l’Italia per la Giornata Mondiale della Poesia e ho avuto da lui il consenso a tradurre e far conoscere la sua opera in Italia. Presento dunque oggi la prima parte del lungo poemetto Voices of the Book of Kells . Mi piacerebbe che questo grandissimo poeta irlandese, molto noto e giustamente celebrato, ma da noi sconosciuto, potesse trovare un editore.
AGGIORNAMENTO 2022
Dopo quanto ho scritto sopra, sulla rivista Poesia di Crocetti è apparsa una breve antologia a mia cura dei suoi testi poetici e nel 2017 è uscita la traduzione del lungo poemetto San Simeone Stilita. Un primo passo è stato almeno fatto.
Francesca Diano
*******
Storia del Libro di Kells (di James Harpur)
Il Libro di Kells è stato associato almeno a tre luoghi: Iona, Kells e Dublino. Alcuni ritengono che fosse proprio il Libro di Kells che Giraldus Cambrensis vide a Kildare alla fine del 12° secolo. Ma chi creò il libro e dove, rimane tuttora un mistero. Ora molti studiosi pensano che sia stato iniziato, se non condotto a termine, nel monastero irlandese di Iona, prima di essere portato nel monastero fratello di Kells dopo l’incursione vichinga dell’806. Rimase probabilmente a Kells negli otto secoli successivi e infine, a metà del 17° secolo, venne trasferito al Trinity College di Dublino, dove è ora esposto.
Il Libro di Kells è un luogo di poesia divina, scritta e visiva e, soprattutto, da una moderna prospettiva, l’archetipo, o il santo patrono di ogni libro. In ogni pagina vi si dispiega un senso di devozione amorevole, di concentrazione e maestria – è chiaro che il libro fu fatto per durare. È anche un libro di sorprendente tensione; il gusto visionario per la totalità si unisce all’ossessione per il dettaglio; il grandioso formalismo statico delle miniature a tutta pagina è bilanciato da spirali vorticose, intrecci nastriformi e fogliame, gatti birichini e topi, lontre e pesci che saltellano in angoli nascosti. Questo libro suscita in ogni scrittore delle domande fondamentali sull’arte; il suo rapporto con l’ispirazione; la moderna preoccupazione per l’ originalità e la voce individuale; lo scopo dell’arte sacra e il suo rapporto con la funzione dell’arte laica o con l’arte in un’epoca laica; la natura dell’immaginazione; la possibilità o meno di rappresentare in forma visibile la verità ultima, ecc.
Premessa di James Harpur
Il poemetto è diviso in quattro parti. Ciascuna è costituita da un monologo pronunciato da un personaggio storico associato a un luogo specifico: L’Orafo (un miniatore), è associato all’isola di Iona; Scriba B (un amanuense), a Kells; Giraldo di Cumbria a Kildare; Lo Scribacchino (uno scrittore moderno) a Dublino. Oltre ad essere imperniata su una ‘voce’ e un luogo specifico, ogni sezione si concentra su di una particolare miniatura del Libro di Kells, sulla sua immagine e sui suoi riferimenti, il tutto intessuto nella trama della narrazione. I metri e i ritmi dei versi riflettono, in certa misura, il carattere dei diversi personaggi. Ad esempio, la voce tagliente dello Scriba B è resa con un trimetro giambico ridotto e leggermente spezzettato (scazonte), mentre il raffinato ed esuberante Giraldo si esprime in pentametri pieni ed estesi.
Prima Parte. L’Orafo (Iona, AD 806)
Nella prima parte compare un miniatore anonimo che lo studioso francese del Libro di Kells, Françoise Henry ha soprannominato l’Orafo, per la sua predilezione per l’orpimento, il pigmento minerale usato per rappresentare l’oro. L’azione si svolge a Iona, poco prima di una devastante incursione vichinga. L’Orafo racconta di come sia arrivato a Iona nel tentativo di salvare la propria vita spirituale dal lassismo di un monastero irlandese e dell’onere di creare ciò che poi diverrà (nella realtà) la famosa pagina del Chi Rho. La sua è la tensione di ogni artista; la pagina o la tela bianca rimane l’eccitante regno del possibile, dell’infinito, fino all’istante in cui il primo segno di inchiostro o di colore riducono l’astrazione del pensiero e del sentire entro i confini del mondo materiale finito. Ed in questo sta il paradosso: la spinta a creare e tuttavia la delusione di non essere in grado di rappresentare la vastità e la ricchezza del sogno. Allo stesso tempo, l’Orafo si strugge sul ruolo che ha come miniatore: è l’opera della sua vita, dedicata a Dio…ma che accadrà una volta che avrà completato il suo ultimo dipinto? Che ruolo avrà allora agli occhi di Dio? Questa parte esplora queste tensioni, che giungono al culmine quando infine l’Orafo si impegna nella sua opera più grande: la pagina del Chi Rho.
**********
A Francesca Diano, con profonda gratitudine e affetto
Costantino Rodio, 9° sec.
Plotino
Sant’Agostino. Sermone 103
Libro di Kells, Folio 34r Matteo 1.18 Chi Rho
Matteo 1. 18
Françoise Henry ha definito il primo e più grande (degli artisti del Libro di Kells) “l’orafo”, perché il suo uso del giallo e dell’azzurro argenteo… evoca l’idea del metallo.
Bernard Meehan, The Book of Kells
La sera deviava la barca
da Mull verso Iona,
un viaggio eco di un grido,
ed io scrutavo l’acqua nel profondo
con l’attenzione di un cercatore d’oro.
Dietro, si levava Dalriada[i]
in monti accesi d’erica, frontiera
di un regno d’ombre.
Alla ricerca di tracce di Columba[ii]
nulla avevo trovato se non pietra
nell’abbazia sferzata dal nevischio,
lastre tombali che andavano in rovina,
l’alloggio grigio ardesia
di vedovo silenzio, fulgore senza rete.
Nessun indizio sui sentieri costieri,
o sulla ritmica erba collinare
e il ginestrone del machair[iii];
o nella “baia del coracle”
dove Columba vide finalmente
che era invisibile l’Irlanda;
o sull’altura di Síthean Mor[iv]
dove un cerchio di angeli apparve
mentre pregava solo in ginocchio
e carezzarono l’aria
con le ali pulsanti, un oratorio
di cigni, che in un alone discendono.
*
Di rado giungono a meta i pellegrini:
i loro santuari scintillanti
non contegno che ossa, gemme,
e santi di cera. Riprovano
come se il viaggio fosse meta
a sé stesso, la prova generale della morte.
O mossi da intuizione
di un ricordo spirituale sepolto,
camminando verso cappelle, sorgenti
o fonti, imitano il percorso [v]
d’ogni cosa creata che ritorna
all’increata origine:
la Fonte
della luce in eterno fluente
che emana forme, o modelli,
da cui deriva il nostro mondo –
cerchio di cosmico exitus,
poi terreno redditus …
I pellegrini seguono trame di percorsi
e ippovie e strade sterrate,
strade romane e viottoli tortuosi;
sfidano fiumi, laghi,
costeggiano paludi, torbiere,
ma la loro visione è sempre diritta,
diretta dalla volontà di raggiungere
una precisa mèta redentiva.
Tuttavia cosa accade quando osiamo
essere audaci come peregrini –
monaci che abbandonano i remi
lasciando che lo spirito nel vento
li guidi lungo il loro viaggio?
Come s’affidarono i Magi ad una stella
o Columba nel suo esilio sul mare
fu diretto da vento e onda fino a dove
trovò la sua Casa,[vi] un approdo
da cui casa era ora invisibile.
*
Attico in un castello scozzese,
Hawthornden,[vii] lontano un mondo;
ho della carta, una cartolina –
in cui tento di decifrare
Christi generatio –
e voglia di scrivere. Ho il vuoto,
come affrontassi un esame
con domande in inchiostro bianco.
Attraverso la finestra sulla torre
guardo un torrente spumeggiare verso est,
giunchiglie piegate dalla neve,
scheletriche scritture d’alberi.
Aprile è rigido in linfa e cellula.
Son mesticato per la “trance poetica”
ma le pressioni della volontà
hanno ancora fallito nel far sì che il silenzio
scenda e riluca, come il sole che sorge
prima che emerga la terra
dalla notte, e gli uccelli son pronti
a rompere l’attesa
e sciogliere versi di lode
all’auctorem regni caelestis.
La carta sul mio tavolo
resta un foglio di ghiaccio.
Respiro profondamente; il ritmo
mi fa ritrarre strato dopo strato
come il sussurrato ripetere
della Preghiera di Gesù,
uniforme quiete marina del respiro…
il vetro della finestra è una cornice
di potente scialbore –
fisso lo sguardo lascio giungere Iona:
una figura sfocata, in controluce,
un monaco, una cella, un leggio da scrivano.
Fa la punta a una piuma,
mormora all’ovattato oceano:
“Signore guidami, dirigi la mia mano, la scelta dei colori.
E dimmi: dovrò ispirarmi a una sembianza umana,
o a qualunque sembianza sia nel mondo?
Le mie dita son grigie e il naso congelato,
la volontà fiaccata da Esichio il Presbitero
che dice solo un cuore svuotato di immagini
può incubare la tua presenza.
Nel mio vellum[viii] è il sacro bagliore
dell’assenza: non linee, parole. Solo luce.
Come posso magnificare il Nulla?
Eppure cosa vi giace, in attesa di balzare
come delfini dal mare, liberi d’inalare
l’aria e gioire dell’esser senza peso?
O come viticci che si tendono al sole
robusti, che alcuno scopo ostacola?
Per fare la tua immagine dobbiamo guardarti;
per guardarti dobbiamo divenire come te –
ogni giorno preghiamo, digiuniamo, puniamo il nostro corpo
come fossimo bestie caudate di sterco –
ma siamo infatuati dei pigmenti e rendiamo
il vellum liscio come seta pura di Bisanzio –
nutriamo i sensi che dobbiamo annichilare.
Signore, devo dipingerti. Ma come?
In carne e ossa, una cosa che s’affloscia,
come farebbero i seguaci di Ario?
Oppure un balenio dello spirito – fuoco fatuo –
il fantasma dei Monofisiti?”
L’osservo mentre osserva il vellum
infliggere le infinite sue paralisi.
Penso: ‘Cristo’ non è una ‘persona’
ma energeia, lux fluens,
ininterrotto fluire di luce che muove
il sole e l’altre stelle[ix]
e semina quella sorta d’amore
che fiorisce quando il sé perde sé stesso.
Penso: Cristo non può essere dipinto,
solo il suo effetto sulla natura –
creazione ch’è stata fatta Cristo.
Voglio dire al monaco: Capitola!
Allora quel ch’è oltre la caverna
del tuo protetto piccolo sé
sciamerà dentro – come api sul trifoglio –
vorticherà come le ruote di Ezechiele –
la tua opera sarà un’arca – per leoni,
aquile, serpi ed angeli,
che si muovono invisibili tra noi –
e linee di luce cristica tutti noi collegheranno
insieme a livello dell’anima.
Non dico nulla. La sua mano è ferma.
*
I giorni gocciolano verso il disgelo,
i boccioli son più viscosi sugli alberi,
le giunchiglie spelano nel giallo
sull’orlo del burrone.
Sogno, ad occhi aperti sogno, vedo Iona
sulla mia pagina, il monaco immobile.
Una volta l’osservo dopo i Vespri
sulla White Strand[x], l’oceano
a cancellare un giorno di insuccessi.
Guardiamo la notte risigillare il cielo
con il buio, ed Orione emergere
sopra Dalriada, come se uno scrivano
stesse forando la pergamena cosmica –
la sua cintura di stelle silenziosa e lucente
quanto i Magi in ginocchio nella stalla.
Christi autem generatio.
Lascia il mare ai suoi incessanti amen,
e fa ritorno all’onere
dell’abbazia, e alla rivalsa del sonno.
La sua cella è gelida come una caverna.
Inizia a pregare e a confessarsi,
lo sento nell’oscurità.
“Signore, mi manca la valle dell’Humber,
la luce tagliente dell’Anglia.
Iona va alla deriva sul mare, ed io son trasportato
dall’accidia alla melanconia.
Ogni giorno rivela i frantumi
della tua creazione; detriti, alghe,
funghi, muffe, foschia satanica,
la carne dolorante, il torcicollo.
Se la creazione non fosse che mestiere
mi basterebbe prendere il coltello,
praticare fori, tracciare linee, cerchi.
Ma ogni punto dà inizio ad una forma
che ho timore possa dileggiarti.
Cerco purezza in pigmenti macinati
per mondare il cervello dai pensieri.
E tuttavia temo che il vuoto della mente
sia lo specchio del vuoto della morte.
Come posso dipingerti Signore?
quali occhi, naso, bocca?”
Sento le sue parole e sento Plotino
scoraggiare un pittore di ritratti:
“È già duro sopportar queste fattezze
che mi furono conferite alla nascita.
Perché dovrei voler lasciare un’immagine
della mia immagine ai posteri?”
Mi concentro sul volto del monaco,
che cosa posso dirgli? …
Non dipingere l’aspetto delle cose
ma le Idee da cui sorgono –
non una rosa, ma la Rosa, in cui
una rosa sarà l’essenza
di ogni rosa; non celebrare il bello
soltanto, o solo quel che è santo e sacro:
includi il disgustoso, il marginale,
il deforme; e quando mediti
lascia avvizzire e perire i tuoi pensieri –
poi, in seguito, in silenzio, potrai scorgere
il divino in tutto quel che vedi:
il tuo pennello sarà la lanterna
che illuminerà il tuo sentiero
verso l’Immaginazione, i suoi raggi
di luce, come un flusso d’energeia,
annienteranno il velo tra il vedente e il veduto.
E lui, come assorto:
“Può il vellum esser casa per Cristo?
Può essere circoscritto da linee –
Colui che è come vento, oceano trascorrente
da un non formato a un altro non formato?”
Penso: dipingi il non formato – dipingilo
attraverso la forma; Cristo era spirito e carne,
e la pittura è incarnazione dello spirito.
Non pensare! Desisti – e il tuo pennello
catturerà lo spirito, solcherà
il mistero della tua pagina
e nei suoi abissi vedrà le ricchezze;
abbi fede; emergerà l’immagine.
Sembra lui voglia lanciarsi
dentro la pergamena intonsa, mentre
io sto per mettere mano alla penna –
insieme, forse, vedremo il Chi
inseguire la gioia nello spazio –
come a recare la notizia straordinaria
che la sorgente è sgorgata finalmente –
ma il nucleo di diamante permane immobile,
spioncino su un mondo ch’è oltre;
e ora si lascia dietro il Rho
schizzando lontano da lune e soli –
e si differenzia, e diviene.
[i] Antico regno goidelico che si estendeva dalle coste occidentali della Scozia alle coste settentrionali dell’Irlanda a partire dal V secolo. (N. d. T.)
[ii] San Columba, in gaelico Colum Cille, (Gartan, 521 – Iona 597) di nobili origini, giunse sull’isola scozzese di Iona, all’epoca parte del regno di Dalriada nel 563 e vi fondò un monastero, divenuto centro importantissimo di spiritualità e cultura. In seguito alle morti provocate dalla “Battaglia del Libro”, fece voto di autoesiliarsi e stabilirsi solo in un luogo da cui non fosse possibile vedere l’Irlanda. A bordo di un coracle, l’imbarcazione rotonda rivestita di pelli tipica dei popoli celtici e ancora in uso in Galles e in qualche luogo dell’Irlanda e delle Ebridi, sbarcò con i suoi pochi monaci in una piccola baia, Port a Churaich, che significa Baia del Coracle, oggi nota come Columba’s Bay.
La battaglia di Cúl Dreimhne, nota anche come “La battaglia del Libro”, fu uno dei primissimi conflitti conosciuti su questioni di copyright, nel VI secolo nella contea di Sligo. Secondo la tradizione, l’abate irlandese San Columba entrò in lite con San Finnian, dell’abbazia di Movilla, a causa di un salterio. Columba copiò il salterio nello scriptorium dell’abbazia di Finnian con l’intenzione di tenersi la copia, ma non di questo parere era Finnian. Il conflitto era dunque sulla proprietà della copia del salterio, se di Columba perché l’aveva copiato o di Finnian che possedeva l’originale. Il re Diarmait mac Cerbaill emise la sentenza che: “Ad ogni vacca appartiene il suo vitello, ad ogni libro la sua copia.”
Ma Columba non accettò il giudizio e istigò una rivolta del clan Uì Néill contro il re. La battaglia vide la vittoria della parte di Columba (che ovviamente si tenne la copia) ma pare abbia causato 3.000 morti. (N. d. T.)
[iii] Machair, letteralmente “pianura fertile”. È il termine gaelico con cui si indicano le verdi praterie dunose o con leggero andamento collinare esclusivamente tipiche di alcune zone costiere della Scozia, delle Ebridi, e dell’Irlanda nordoccidentale. (N. d. T.)
[iv] Il nome significa “la collina delle Fate” e si dice che lì Columba fu visitato dagli angeli. (N. d. T.)
[vi] In originale Home, dimora, il luogo cui apparteniamo, affettivamente connotato, distinto da house, la casa come edificio. In tutto il testo Harpur usa questo termine che ho tradotto “casa”, non essendoci in italiano un termine semanticamente corrispondente e distintivo. (N. d. T.)
[vii] Il castello del XV secolo, ampliato nel XVII, si trova a poca distanza da Edimburgo. Dopo vari passaggi di proprietà, è stato acquistato e restaurato negli anni ’80 dalla famiglia Heinz, quella dei famosi cibi in scatola, e trasformato in un ritiro internazionale per scrittori, che vengono ospitati per un mese. (N. d. T.)
[viii] Il vellum era la pergamena di qualità migliore e più costosa, ricavata in genere da vitellini o da capretti o vitellini nati morti, dunque molto morbida e sottile. Veniva lavorata lungamente per ottenerne un supporto alla scrittura perfettamente liscio, resistente e il più bianco possibile. In genere, da un animale usato per il vellum, si ottenevano tre, al massimo quattro fogli. Per il Libro di Kells è appunto stato usato il vellum. (N. d. T.)
[ix] In italiano nel testo. (N. d. T.)
[x] White Strand of the Monks è la bellissima spiaggia bianca di frammenti di conchiglie su cui avvenne la strage dei monaci dell’Abbazia di Iona da parte dei Vichinghi. (N. d. T.)
(C)by Francesca Diano RIPRODUZIONE RISERVATA
30 Lug 2013 Lascia un commento
in Anita Nair, Bhagavad Gita, Dharma, Francesca Diano, Francesca Diano traduttrice, india, indian literature, indian women writers, indian writers, Krishna, miti indiani, mitologia indiana, scrittori indiani, Uncategorized
ANITA NAIR E IL MITO
di Francesca Diano
Prefazione a
Magical Indian Myths
di Anita Nair
Il mito è uno strumento di precisione, tagliente come un rasoio, profumato e profondo come le acque dell’oceano, vasto e complesso come l’intero cosmo, per proiettare una lama di luce nella tenebra dell’animo umano e della storia della nostra specie.
Il mito è la storia prima della storia, il suo tempo è il non-tempo. Quando tra uomini e dèi non v’era separazione. Quando la natura parlava all’uomo con parole che l’uomo intendeva.
Scelgo volutamente di usare il termine al singolare, perché per la mia pur modesta esperienza di innamorata di miti, sono sempre più convinta che non vi sia alcuna separazione tra i patrimoni mitologici che le diverse culture ci hanno lasciato, come zolle tettoniche galleggianti su un magma ignoto.
Esiste il mito ed esistono le sue proteiformi manifestazioni, che si diramano nel tempo e nello spazio in infinite direzioni e gemmazioni, che tessono trame senza fine. E segnano di sé ciascuna cultura, tanto che forse non è una cultura che crea i suoi miti, ma l’opposto.
Sorella del mito è la fiaba. O a dir meglio, figlia. Ché ne è generata in sfilacciature e brandelli, ma il cui fine è ugualmente nobile.
Il mito è cibo per uomini dal cuore di bambini. La fiaba è nutrimento per bambini il cui cuore sarà quello di uomini.
E da sempre pare che il compito di traghettare la memoria di questi due mondi apparentemente separati sia stato quasi ovunque accuratamente ripartito tra i due sessi: narratori di miti sono gli uomini; narratrici di fiabe sono le donne. E mi piacerebbe avanzare un’ipotesi per questa divisione di ruoli, che assegna alle donne il ruolo di psicopompo nel passaggio dall’infanzia all’età adulta.
In ogni momento liminale la donna è presente: la nascita, la morte. Sono donne le prefiche, sono le donne che preparano il defunto per il grande viaggio verso una nuova vita e ne accompagnano il passaggio con la lamentazione funebre ritualizzata. Che altro non è che la narrazione di una vita che, in quell’istante, si spoglia della sua dimensione individuale ed entra nel mito. Esce dal tempo umano per fondersi col divino.
La Grande Dea Madre dà la vita e dunque dà la morte. Ma la morte è trasformazione, passaggio da uno stato a un altro. E dunque dà la Vita.
È quindi femminile il compito di accompagnare il bambino sino alla soglia della sua trasformazione in adulto, nell’atto di morire all’infanzia e rinascere per la seconda volta, pronto ad entrare nella società degli uomini. Perché la fiaba non è altro che questo, “Vita: istruzioni per l’uso”.
Il mito dunque narra la nostra storia collettiva e anzi ancor prima che l’uomo fosse, conserva la memoria delle origini; la fiaba ci istruisce su come di quella storia entrare a far parte in modo protetto e sicuro.
Ma tutti questi narratori, questi traghettatori della nostra identità, le cui voci, pur non tacendo, sono ormai silenziose, hanno un dono speciale che le accomuna, ed è l’abilità, l’arte di narrare.
Il dio degli antichi Celti, Oghmé, una sorta di Eracle celtico, ma anche dio dell’eloquenza e della parola, aveva catene d’oro che si dipartivano dalla sua lingua e letteralmente avvincevano chi l’ascoltava.
Dunque la narrazione non può essere separata dal suo narratore.
Ed ecco che una donna, una donna indiana, che sa usare le parole come catene d’oro nelle sue narrazioni, sceglie di raccontare ai bambini i miti dell’India.
Perché questo è nato come libro per bambini e non a caso è dedicato a Maitreya, suo figlio.
Per i bambini indiani, ai quali i nomi e le intricatissime vicende di quegli dei, di quei semidei, di quei demoni e re mitici, di quegli animali divini non suonano affatto sconosciuti. E così è per qualunque indiano, piccolo o grande.
Qualche anno fa, una serie televisiva durata due anni e tratta dal Mahabharata, paralizzò l’intera India davanti agli schermi TV.
In India il mito, l’epopea, appassionano quanto le trame dei film di Bollywood, che non se ne discostano poi così tanto.
Donna dunque. E indiana. Che si assume il compito di tramandare ciò che è stato narrato a lei da sua madre, da sua nonna e dalla cultura che ha respirato, dal mondo in cui è nata, parte di quello che è tra i più antichi e fecondi patrimoni di miti dell’umanità.
Ma in questa scelta, io credo, non entra in gioco solo la sua arte narrativa, che si riconosce dallo stile che le è proprio, diretto, tutto dialogo, poche descrizioni, ricco di colpi di scena, di ironia, poesia e dramma, quanto anche la sua identità.
Anita Nair appartiene a un antico gruppo etnico, da tempo immemorabile presente nel Kerala, che è lo stato dove è nata e dove torna spesso, quello dei Nair o Nayar, per tradizione guerrieri, storici e viaggiatori. Una colta aristocrazia in uno degli stati indiani in cui di fatto l’alfabetizzazione è quasi totale. Ma l’aspetto più singolare e interessante di questa etnia dalle origini antiche e misteriose, è quello della discendenza matrilineare, che dà alla donna una posizione di grande potere e preminenza, sia all’interno della famiglia che del gruppo sociale.
I figli sono figli della madre, la figura maschile più importante all’interno della famiglia non è il padre, ma lo zio materno, la trasmissione del patrimonio è per via femminile, ecc. Una tradizione opposta a quella in genere presente nella cultura indiana, secondo cui il ruolo della donna, familiare e sociale, è assolutamente di sudditanza.
Dunque, per tradizione antica, spetta in qualche modo alla donna preservare e tramandare l’identità culturale e sociale del gruppo.
In questo Anita Nair, in un certo senso, non fa eccezione.
Nella sua premessa, Anita Nair specifica difatti che il suo desiderio altri non è che quello di ritrovare la magia delle voci narranti che le hanno fatto amare questi miti e queste leggende ascoltate dalla madre, dalla nonna e più di recente dal maestro di danza Kathakali da lei incontrato in Kerala nel corso delle ricerche per la stesura del suo romanzo Padrona e amante.
Conosco l’opera di Anita Nair fin dagli inizi e ho della sua scrittura una visione privilegiata, come traduttrice e come lettrice. A lei mi legano anche un’amicizia e un affetto profondi.
Un traduttore che abbia la fortuna di seguire da sempre un autore, e ancor meglio fin dai suoi esordi, lo conosce dall’interno, ne segue i meccanismi del pensiero, ne impara la mappa mentale, ne vede l’evoluzione come nessun altro. Perché deve smontare quei meccanismi della lingua e del pensiero per ricostruire e rendere quello stile, quella unicità. Deve dargli una voce straniera che sia all’autore familiare quanto la sua originaria.
Dunque ho imparato a conoscere anche la sua visione del mondo.
Le storie che Anita narra, storie di donne e di uomini, ma soprattutto di donne nell’India che cambia, parrebbero lontane dal mondo della sfolgorante mitologia della sua terra.
Donne quasi sempre della media e alta borghesia, le cui vite si scontrano con i sussulti del progresso, dei veloci cambiamenti sociali, delle tradizioni che non si vogliono o possono dimenticare. Quello che racconta, con passione, delicatezza, ironia e un’acuminata capacità di andare al cuore delle cose, è un mondo in cui le trasformazioni sono velocissime e creano un senso di smarrimento. Storie la cui fine è con grande intuizione sempre aperta, in cui i suoi personaggi femminili devono fare i conti con le turbolenze create dallo scontro fra tradizione e innovazione.
Generalmente la tradizione è rappresentata dai personaggi maschili, mentre i personaggi femminili sono portatori di cambiamento e trasformazione. Uno scontro fra passato e futuro dunque, che non può avere una soluzione immediata o certa.
Ma il passato è sempre presente, in una sorta di contemporaneità del sentire, perché il Kerala in cui Anita Nair colloca tutte le sue storie, è un luogo ricolmo di incanto e bellezza, di magia, di vicende tratte dal Ramayana e dal Mahabharata che i danzatori di Kathakali rappresentano davanti ai templi al tramonto, indossando i loro abbaglianti costumi. Ed è a quel passato mitico e magico che Anita Nair attinge.
In Un uomo migliore, la storia di una morte e di una rinascita spirituale è ambientata in un piccolo villaggio del Kerala, che diviene una sorta di microcosmo universale, dove una magica tecnica di guarigione, ispirata a un racconto puranico dà i suoi frutti. In Padrona e amante la vicenda amorosa dell’indiana Radha, moglie di Shyam e dell’americano Chris (i nomi rimandano agli dèi Radha e Krishna e a uno degli appellativi di Krishna, Shyamasundara, il Bello e l’Oscuro), si intrecciano con storie dalle coloriture di epopea e con la descrizione delle antichissime tecniche sacre della danza Kathakali, che mette in scena i miti e i racconti epici.
Anita Nair rifiuta la definizione di “realismo magico”, che alcuni hanno avanzato per lo stile della sua scrittura e, dandole ragione, io lo definirei piuttosto “realismo mitico”.
Alla luce di queste premesse allora, non sarà difficile capire le ragioni di questo libro.
Il desiderio di rendere vividi e vitali i miti della sua terra trasformandoli in racconti ricchi di azione, di colpi di scena, di personaggi che parlano un linguaggio direi moderno e diretto per i piccoli lettori. Lettori che conoscono i miti della loro tradizione anche attraverso i fumetti e i cartoni animati. Tanto è presente il mito in India, che non teme di perdere forza o potenza mutando linguaggio.
Ma che questo libro sia indirizzato ai bambini non inganni, né faccia pensare a una lettura di tutto riposo, per quanto lieve e piacevole perché, sotto gli occhi dell’Occidente, il suo senso muta.
Il nostro cinismo, il nostro disincanto ci hanno fatto perdere la capacità di intendere il senso universale di quelle storie e tuttavia una nostalgia ci afferra, di ritrovare il linguaggio del mito, che ancora sussurra dall’abisso del tempo.
Ma per noi quel linguaggio non sarà più diretto. La luce del mito per noi sarà un lucore. Come la lucina nel bosco, lontana lontana, che compare salvifica nelle fiabe. Dovremo dunque imparare ad attraversarlo quel bosco che ce ne separa.
Pensare di dedicare “qualche parola” alla mitologia indiana, o anche “qualche pagina”, in una prefazione può produrre un unico risultato: paralizzare il povero prefatore. Tanto più se questa, come me, non è un’indologa o una storica delle religioni, ma solo un’innamorata del mito. Il fatto è che la mitologia indiana, la madre di tutte le mitologie, è forse uno dei patrimoni mitologici più sterminati, compatti e antichi che vi siano.
Miti, leggende, racconti epici si trovano nel Ramayana, nel Mahabharata, nei Purana. Letteralmente centinaia di migliaia di pagine. Narrazioni di gesta e imprese di un numero immenso di divinità, maggiori e minori, di personaggi semidivini, di animali magici, di avatar, incarnazioni di un dio. Vicende che si diramano in infiniti rivoli, intrecci, mutazioni, senza soluzione di continuità. E tutto questo macrocosmo narrativo, dai mille simboli convoluti, dai significati spesso inafferrabili, nel suo complesso, i cui confini si perdono nell’ignoto, è l’immagine dell’intero universo.
Come era, come è e come sarà. Tuttavia, in India, non esiste una rigorosa separazione tra mito, leggenda e fiaba o, se esiste, è talmente sottile da non poterla discernere.
La fiaba, come noi la conosciamo, è ciò che resta del mito, la sua trasformazione in racconto popolare e così è accaduto per noi in Occidente. Dove i miti sono solo materia di studio, ma non fanno parte più ormai della nostra vita quotidiana.[1] Ed è accaduto già da molto tempo.
In India non è così. E diversa è anche la concezione del tempo. Il tempo del mito, che inghiotte, trasformandoli nella sua stessa sostanza, anche avvenimenti storici, è il tempo del sacro. Un tempo circolare in cui non vi è un prima e un poi, ma tutto convive in un eterno presente e la narrazione delle vicende, che apparentemente si succedono le une alle altre, non segue un ordine cronologico, ma solo di causa-effetto, al di fuori del tempo e dello spazio.
Perché in India, così come nelle culture antiche, il mito è la storia. E questa percezione del tempo in India è ancora presente. La tradizione, con la sua ricchezza insostituibile è parte del quotidiano. Soprattutto nell’arte. Se si pensa che i musicisti e i danzatori in genere discendono da tradizioni familiari ininterrotte che possono risalire anche a seicento anni. Così come nella medicina. Patrimoni di conoscenza affidati alla trasmissione della teoria e della pratica.
Troppo lungo sarebbe e non utile in questa sede approfondire oltre questo discorso, ma ciò che è importante comprendere è che l’occhio e la mente con cui noi leggiamo questi racconti non può essere e non sarà mai quello con cui li legge un indiano, adulto o bambino che sia.
La maggior parte dei miti che Anita Nair ha scelto per compilare questa raccolta sono tratti dai Purana, dal Mahabharata e dal Ramayana, ma con delle incursioni nei testi vedici.
La tradizione letteraria indiana comprende i 4 Veda con i relativi commentari (tra cui le Upanishad), che contengono inni, canti, riti e formule magiche. Questi testi sono noti come shruti, letteralmente “ciò che è stato udito”, perché furono rivelati in tempi immemorabili come suono attraverso l’orecchio ai rishi, sacri sacerdoti o veggenti primordiali, che a loro volta li hanno trasmessi oralmente ai sacerdoti brahmani e così passati di generazione in generazione. Il termine sanscrito veda ha la stessa radice di video latino, dunque il suo senso è “veggenza”. Anche se furono rivelati attraverso il suono, poiché ciò che si vede si conosce. Dunque conoscenza. [2]
La smriti , letteralmente “ricordo”, è invece la tradizione orale e popolare di miti, leggende, poemi epici e comprende I Purana, il Mahabharata e il Ramayana.
Il Mahabharata è l’epopea di circa 100.000 versi in cui si narrano le vicende della lotta tra le famiglie imparentate dei Pandava e dei Kaurava per il trono. Sarà grazie all’aiuto di Krishna, auriga dei Pandava, che a questi arriderà la vittoria.
Ed è nel Mahabharata che compare la Bhagavad Gita, il Canto del Beato, il discorso di Krishna ad Arjuna, in cui è affermato e spiegato il senso del Dharma.
Il Ramayana, composto da 27.000 versi, narra la vita di Rama, avatar di Vishnu al pari di Krishna, dall’infanzia al suo ritorno nella città di Ayodhya.
I Purana costituiscono uno sterminato corpus composto da 18 Purana maggiori (Maha Purana) e 18 minori (Upa Purana), la cui composizione è attribuita al mitico rishi Vyasa, o Vyasadeva. [3]
I Purana maggiori sono interamente dedicati alla Trimurti, la sacra trinità di Brahma, Vishnu e Shiva, a ciascuno dei quali sono riservati 6 Purana. Inoltre genealogie mitiche di sovrani, personaggi semidivini, asura (demoni) e le loro vicende, che si intrecciano con quelle degli dèi. Vi si narrano la vita, le gesta, i culti e i loro avatar, o incarnazioni. Nel Bhagavata Purana ad esempio, sono elencati i Dasavatara, i 10 principali avatar, le 10 incarnazioni di Vishnu: Matsya, il pesce; Kurma, la testuggine; Varaha, il cinghiale; Narasimha, l’uomo-leone; Vamana, il nano; Parashurama, Rama con la scure, l’abitante della foresta; Rama, il Signore del Regno di Ayodhya; Krishna; Balarama o Buddha; Kalki, il Tempo, colui che annienta la malvagità, che giungerà su un cavallo bianco alla fine del Kali yuga, l’età oscura, la nostra epoca, dominata da materialismo, avidità e cinismo, per riportare l’umanità a ritrovare la sua identità divina dopo una catastrofe purificatrice.
Ma non si tema, perché l’inizio del Kali yuga data dalla morte di Krishna, il 18 febbraio 3.102 a.C. e gli yuga, le ere secondo i Veda, durano molte centinaia migliaia di anni. Quest’ultima durerà poco meno di 430.000 anni. Dunque siamo appena agli inizi!
Una lettura interessante e di grande fascino è che questi 10 principali avatar di Vishnu indichino i dieci stadi evolutivi dell’umanità; dagli organismi viventi nel brodo primordiale (pesce), agli anfibi (testuggine), agli stadi non ancora del tutto umani (nano e uomo-leone) fino allo stadio più evoluto in cui l’umanità troverà finalmente la sua identità divina in un’Età dell’Oro.
Come si vedrà, tra i primi miti che Anita Nair narra, ve ne sono cinque dedicati ai primi cinque avatar di Vishnu. Sono quelli in cui Vishnu scende sulla terra in forma ancora non umana o semi-umana. Il dio Vishnu, il Conservatore, mantiene la stabilità della creazione e dell’ordine cosmico, contribuendo alla realizzazione della legge del Dharma[4]. I suoi interventi, nei momenti in cui operano forze oscure e distruttive che tenderebbero a prevalere e distruggere quell’ordine, sono fondamentali perché si compia il Dharma. Ed ecco che in momenti di pericolo Vishnu discende sulla terra assumendo la forma necessaria e adatta. La legge del Dharma richiede che non solo l’Universo, ma ciascun essere si conformi a quell’armonia che sola garantisce l’equilibrio dell’Esistente.
Forse, leggendo questi miti, non si potrà non pensare agli dei dell’Olimpo, risplendenti di luce, ma a volte capricciosi e irosi. Anche qui, dèi e re mitici, demoni, saggi rishi e avatar, si scontrano in lotte dettate da gelosie, egoismo, avidità. Come nel mito “Come nacque il Lingam”, in cui Brahma e Vishnu litigano come bambini viziati per stabilire chi sia il vero creatore dell’Universo, incuranti che il loro dispettoso scontro rechi morte e distruzione tra gli uomini. Ed ecco: un’immagine da Guerre Stellari, da effetti speciali che nemmeno Spielberg. Emerge dall’oceano cosmico, tra esplosioni di fuoco e di lampi, una misteriosa roccia oscura, che cresce sino a proporzioni gigantesche. E cresce e cresce e cresce e poi si spacca…. E il Signore Shiva, in silenzio, sul suo trono, vi è dentro come in un tempio. La tremenda potenza del Lingam, simbolo ben più complesso e misterioso che di un semplice fallo umano, origine della vita, che è principio, ma allo stesso tempo fine, morte, trasformazione e rinascita.
Dunque è Shiva, il Distruttore, il vero creatore dell’Universo. Non Brahma, da cui tutto emana, non Vishnu, che protegge e mantiene, ma Colui che distrugge. Perché senza distruzione non v’è trasformazione e dove non v’è trasformazione è la morte di ogni cosa. Perché dove è la Fine lì è anche l’Inizio. Shiva è infatti Adianta: inizio e fine.
Allora ecco che anche l’apparente disordine dei comportamenti divini, le liti, le diatribe, le rabbie e le vendette, tutto non è altro che un mezzo per far sì che il Dharma si affermi, che la Verità si riveli.
Questo insegnamento accomuna in India mito e fiaba. Questo intendono i bambini indiani leggendo i dialoghi vivaci, le descrizioni quasi sceneggiate dei miti come Anita Nair li racconta.
Il racconto che Anita Nair ha scelto come conclusivo, “Del perché Yama non poté ignorare Nachiketa”, forse è quello che, tra tutti, più disvela con quale disposizione, background e intendimento un bambino indiano leggerà questi testi. Una disposizione che nessun bambino occidentale potrà mai avere.
La storia di Nachiketa, che narra dell’origine delle Upanishad, è la storia di un viaggio nell’aldilà e, allo stesso tempo, ricorda come i rishi appresero la shruti. Come Buddha, Nachiketa è colpito dall’esistenza della morte e non ne comprende il senso. Per quanto chieda, nessuno sa dirgli con certezza se vi sia o meno una vita dopo la morte. Il bambino, che pure studia in una gurukula, una scuola retta da un Maestro, non trova risposta né dai maestri né dai compagni. Le circostanze vogliono che Nachiketa raggiunga, per un sacrificio offerto da suo padre, l’Aldilà, dove incontrerà Yama, il dio della morte. Ed è Yama infine, colpito dalla sete di conoscenza di Nachiketa, che gli rivelerà come dono il supremo insegnamento sulla scelta che l’uomo ha nella vita; il saggio sceglie il percorso del bene e la realizzazione del Sé, lo stolto sceglie la facile via del piacere, che lo condurrà alla prigionia della ruota incessante di morti e rinascite. E da questa e le successive rivelazioni di Yama, ebbero origine così le Upanishad.
Questo tipo di insegnamento, trasmesso con queste parole apparirebbe davvero di difficile digestione per uno dei nostri bambini, a cui tra l’altro non parliamo mai della morte. Sono le parole che molti adulti partiti dall’occidente si sono sentiti ripetere dai guru indiani che tanto piacciono alla nostra epoca disincantata.
Se un bambino indiano è in grado di comprendere un concetto per noi tanto elusivo, chi tra i lettori indiani e quelli occidentali di questo libro sarà il vero bambino e chi il vero adulto?
Copyright © Francesca Diano 2009
Tutti i diritti riservati. La copia anche parziale di questo articolo in ogni forma o con ogni mezzo è severamente vietata se non autorizzata a mezzo scritto dall’Autore. I trasgressori saranno perseguiti nei termini di legge.
[1] A questa osservazione fa eccezione l’Irlanda, dove, per molti versi, ho trovato singolari ma comprensibili analogie con la visione indiana del mito e la sua percezione. Se in Irlanda mitologia e folklore sono materia di studio scolastico e ovviamente accademico, tuttavia per un irlandese la propria identità è legata in modo inscindibile alla tradizione orale come per nessun altro popolo in Europa.
[2] La stessa tradizione si ritrova intatta nella religiosità degli antichi Celti. La Conoscenza fu trasmessa in forma di suono emanato ai druidi primordiali e da loro trasmessa oralmente attraverso le generazioni di druidi. Il termine druvid, sul cui significato non sempre si è d’accordo, ha comunque questa stessa radice vid- e il suo significato è “veggente”.
[3] Al brama rishi (saggio sacerdote di epoca mitica) Vyasa è attribuita la composizione dei Purana, del grande poema epico Mahabharata e la trascrizione dei Veda, prima tramandati in forma orale.
[4] Dharma è un termine sanscrito che compare già nei Veda. Il suo significato è molteplice e assai complesso. Ciò che è Stabile, Fissato, Legge, legge Naturale, Ordine Universale, è il concetto centrale della spiritualità e della filosofia hindu. È la Verità Ultima, il senso delle cose, Dio.
Lo si intende sia sul piano individuale, come Legge Morale, dottrina morale dei diritti e dei doveri a cui ciascun individuo deve conformarsi, che sul piano universale. In quest’ultima accezione è il Tao dei cinesi e il Lògos dei Greci. Allontanarsi dal Dharma significa sconvolgere l’ordine delle cose, creare disarmonia, kaos. Dunque sofferenza. Il Dharma è essenziale anche nei diversi stadi della vita umana, Artha, (i conseguimenti materiali) Kama (il piacere sesnsuale) e Moksha (la liberazione) Nel Mahabharata è Krishna stesso a definirlo: “Il Dharma governa tutte le vicende che sono di questo mondo e fuori di questo mondo” (Mahabharata 12.110.11) Ancora Krishna, nel Bhagavad Gita, dichiara di incarnarsi ogniqualvolta e come sia necessario per annientare le forze del Male e proteggere il Bene. Non è un caso che alcune direzioni filosofiche hindu vedano in Cristo e Krishna profonde analogie, di funzione e di ruolo. Non ultimo persino nell’omofonia del nome.
(C) 2009 by Francesca Diano RIPRODUZIONE RISERVATA
02 Lug 2013 6 commenti
in Francesca Diano, Francesca Diano traduttrice, Tim Parks, traduttore, traduzione letteraria, traduzioni
Tim Parks è, come molti sanno, un signore britannico, nato a Manchester, che vive da moltissimi anni in Italia e, per certi versi, la conosce più di molti italiani e per due motivi: la osserva dall’interno e contemporaneamente dall’esterno. La (ci) osserva con grandissima attenzione, acuta curiosità e cura estrema. Questa sua meticolosità (tratto che lui stesso menziona in questa intervista) è riflessa nelle attività che il suo carattere e il destino lo hanno portato a svolgere; scrittore, traduttore, docente di traduzione specialistica allo IULM e molte altre cose. I suoi molti romanzi, Lingue di fuoco, Europa, Il destino di Cleaver, Il sesso è vietato, per non citarne che alcuni tradotti in italiano, e i molti saggi, Italiani, Un’educazione italiana, Questa pazza fede, La fortuna dei Medici, Insegnaci la quiete, Italian Ways, Tradurre l’inglese, solo per menzionare pochi titoli, sono ricchissimi di questa vista acuta come un rasoio, attentissima e talvolta impietosa, ma mitigata sempre da un’elegante ironia. Dote senza la quale la vita sarebbe pesante e forse invivibile. E di pesante in Tim Parks non c’è proprio nulla.
Ma la mia curiosità questa volta era per il traduttore. Parks ha alle spalle una ricchissima esperienza di traduttore, cioè di traghettatore di una cultura verso un’altra – che è il vero scopo della traduzione. Moravia, Tabucchi, Calvino, Calasso sono alcuni degli autori che ha tradotto dall’italiano. Ma la grande sfida per un traduttore è tradurre i grandi capolavori del passato che spesso si leggono in una lingua non più nemmeno corrente nel proprio paese e dunque complessa da affrontare oggi. Ho il sospetto che Parks, che è un grande scrittore contemporaneo, ami molto le sfide, altrimenti come avrebbe potuto affrontare prima Machiavelli e ora lo Zibaldone di Leopardi? Roba da far tremare i polsi a chiunque. Non solo a uno straniero, per quanto profondo conoscitore della nostra cultura, della nostra lingua, della nostra letteratura e delle nostre idiosincrasie, ma perfino a un italiano, dato che questo è il paese in cui si pubblicano, assurdamente per me, “traduzioni” in italiano moderno di grandi classici del passato.
Perciò questa sua impresa eroica di affrontare un testo che è un abisso come lo Zibaldone, mi ha spinta a porgli qualche domanda, a cui Parks ha risposto molto gentilmente e pazientemente. Da traduttrice letteraria da oltre 30 anni e come figlia del maggiore traduttore del ‘900 dei tragici greci, il tema della traduzione dei grandi mi sta molto a cuore. Voglio anche riportare un bell’articolo di Parks sul ruolo (misconosciuto e sottostimato) del traduttore, comparso su The Guardian nel 2010, in cui Parks dispiega tutto il suo acume, la sua esperienza, la sua passione e la sua ironia per sostenere il ruolo fondamentale che ha un traduttore letterario nella cultura del suo paese.
http://www.guardian.co.uk/books/2010/apr/25/book-translators-deserve-credit
Ringrazio Tim Parks per la sua generosa disponibilità e per la sua gentilezza.
F.D.
D. Nello Zibaldone (19 ottobre 1821) Leopardi afferma: “[…] una tal lingua può […] adattarsi alle costruzioni e all’andamento di qualsivoglia altra lingua con somma esattezza. Ma l’esattezza non importa la fedeltà ecc. ed un’altra lingua perde il suo carattere e muore nella vostra, quando la vostra nel riceverla, perde il carattere suo proprio, benché non violi le sue regole gramaticali. Omero dunque non è Omero in tedesco, come non è Omero in una traduzione latina letterale, giacché anche il latino così poco adattabile, pur si adatta benissimo alle costruzioni ecc. massimamente greche, senza sgrammaticature, ma non senza perdere il suo carattere, né senza uccidere e se stesso, e il carattere dell’autore così tradotto. […] Laddove la lingua italiana […] può nel tradurre, conservare il carattere di ciascun autore in modo ch’egli sia tutto insieme forestiero e italiano. Nel che consiste la perfezione ideale di una traduzione edell’arte di tradurre.” E, pochi giorni prima aveva scritto: “La piena e perfetta imitazione è ciò che costituisce l’essenza della perfetta traduzione.” Lei sta traducendo lo Zibaldone di Leopardi. Sta dunque traducendo non solo un grandissimo poeta e pensatore, ma anche un grandissimo traduttore, le cui idee sulla traduzione sono modernissime e anticipatrici. Trova che queste parole di Leopardi si attaglino alla sua esperienza di traduttore, in particolare di grandi autori italiani del passato? Può essere, in qualche modo, una traduzione, una sorta di nuova creazione?
R. Innanzi tutto mi sembra pertinente l’osservazione di Leopardi che anche quando una lingua accetta le forme grammaticali dell’altra, non vuol dire che la traduzione sarà bella o fedele; le forzature nella traduzione, dove non ce ne sono nell’originale, sono una grave infedeltà. Non credo però che questa sia un’idea particolarmente nuova, né che le idee che Leopardi aveva in questo campo siano modernissime e anticipatrici. Humbolt e Schleiermacher erano tutti e due più o meno dello stesso avviso. Anzi non credo che il ventesimo secolo, con tutta la sua furia di Translation Studies, abbia aggiunto nulla di sostanziale a quello che già era stato pensato e scritto sulla traduzione.
Per quanto riguarda la mia traduzione di una selezione dallo Zibaldone, deve per forza essere una nuova creazione, in quanto deve dare voce a questi passi di Leopardi in una lingua e in un tempo piuttosto lontani dall’originale. Detto questo, ogni mio atto creativo è volto a recuperare quello che io comprendo e sento nell’originale, che è una creazione molto, ma molto più importante della mia.
D. Lei ritiene che si possa parlare di “teoria e scienza della traduzione”, o “traduttologia” secondo la definizione di Berman? E se sì, in che senso? Potrebbe essere un diverso modo di definire qualcosa che è sempre stato il bagaglio di un vero traduttore, e cioè un’approfondita analisi filologica, un rigore critico e una profonda conoscenza del testo, dell’autore e della cultura cui appartiene?
R. Non credo alla possibilità di una teoria rigorosa e sistematica. È possibile però trovare modi utili per esprimere quello che l’esperienza e l’osservazione hanno fatto capire. Devo dire che pochi traduttori ci riescono, ma qualcuno lo fa, riesce cioè a farci capire quello che è in gioco nelle infinite scelte che ogni traduzione, per quanto umile, richiede.
D. Lei è un profondo conoscitore del nostro paese e della nostra cultura, ma è anche uno scrittore. Quanto incide, nella sua attività di traduttore, la sua attività di scrittore, o viceversa? Trova che questo la aiuti nel tradurre e trova delle differenze – al di là di quello che potrebbe apparire ovvio ed evidente – fra lo scrivere i suoi testi e il tradurre testi di altri autori? E crede che, per un traduttore letterario, sia importante essere anche, se pur non solo, uno scrittore?
R. Credo che si possa tradurre benissimo senza essere affatto uno scrittore, anche se bisogna ovviamente saper scrivere, che è tutt’altra cosa. Per uno scrittore tradurre è una forma di evasione, perché non gli chiede di decidere cosa scrivere, ma solo di cercare di trasporre l’altro testo nella propria lingua. Per certi aspetti tradurre può essere più difficile, tecnicamente e intellettualmente che non lo scrivere, ma comunque, su un altro piano, è pur sempre più facile. Per quanto mi riguarda, tradurre mi aiuta a riconoscere lo stile che mi è proprio, in quella tensione inevitabile che emerge tra lo stile dell’originale e il modo in cui io sono tentato di renderlo in inglese. Ho imparato moltissimo dalle traduzioni che ho fatto.
D. Un suo libro particolarmente prezioso per chi si occupa di traduzione letteraria è Tradurre l’inglese, in cui lei dimostra, con metodo comparativo, come sia molto facile cadere in fraintendimenti, quando non i errori macroscopici, sia per disattenzione (il che è grave), che per poca conoscenza dell’autore, della lingua e della cultura originale (il che è ancora più grave). Ritiene che gli editori italiani siano troppo poco attenti nell’affidare certi autori a traduttori non sempre così esperti?
R. Non solo gli editori italiani… non si fa che lodare la letteratura, si insiste nel dire che è il sommo prodotto di un’arte raffinatissima, e poi si smistano le traduzioni dei romanzi come se fossero compitini assegnati ai ragazzi in una colonia estiva. È rarissimo che un editore offra davvero il sostegno necessario a tradurre davvero bene un romanzo importante. Quando si pensa alle condizioni in cui vengono ritradotti in questo periodo i grandi classici degli anni venti e trenta del secolo scorso, ti viene da piangere.
D. Quali sono le caratteristiche che un traduttore letterario dovrebbe avere secondo lei?
R. Al di là della conoscenza delle lingue e delle letterature delle due culture in questione, ho sempre pensato che bisogna possedere due qualità in evidente conflitto tra di loro: una straordinaria e rispettosa meticolosità e, simultaneamente, una grande, generosa, impazientissima creatività.
(C) by Francesca Diano RIPRODUZIONE RISERVATA
23 Mar 2013 5 commenti
in Edgar Allan Poe, Francesca Diano, Francesca Diano traduttrice, Poe Francesca Diano, Poe La dormiente, poesia, tradurre poesia, traduzione letteraria, traduzione poetica
Samuel Melton Fisher (1856-1939) DREAMS
LA DORMIENTE (1831)
A mezzanotte, nel mese di giugno
Sotto una luna mistica.
Vapori oppiati, oscuri, rugiadosi
Svaporando dal suo aureo confine
E gocciolando molli, goccia a goccia,
Sopra la vetta placida del monte
Scendono pigri e in toni musicali
Giù verso la vallata universale.
Sopra la tomba ammicca il rosmarino;
Il giglio ondeggia sopra la corrente.
Avvolgendo la nebbia attorno al petto
La rovina si sgretola assopita;
Guarda, simile al Lete! Il lago
Pare si voglia abbandonare al sonno
E non svegliarsi più per nulla al mondo.
E dorme ogni Bellezza! – ed ora guarda
Irene e i suoi Destini!
Oh dama risplendente! Sarà mai bene
Questa finestra aperta sulla notte?
Brezze impudiche, dalle cime degli alberi
Scivolano dentro ridendo dalla grata –
Le brezze senza corpo, un tumulto immagato,
Vanno e vengono lievi dalla stanza
Agitando la tenda a baldacchino
Così brusche – così terrificanti –
Sulle palpebre chiuse e sulle ciglia
Che nascondono l’anima assopita,
Che come spettri s’allungano le ombre
Sul pavimento e lungo la parete!
Oh cara dama, non hai tu paura?
Perché e che cosa stai tu qui sognando?
Tu certo vieni da lontani mari
A stupire le piante del giardino!
Strano il pallore e strana la tua veste!
Ma ancor più strane le tue lunghe trecce
E l’assoluto di questo silenzio!
Dorme la dama! Oh possa il suo riposo
Ch’è persistente essere profondo!
E l’abbia il Cielo nel suo sacro abbraccio!
In una stanza più sacra di questa
Ed in un letto di questo più mesto
Io prego Iddio che lei possa giacere
Per sempre ad occhi eternamente chiusi
Mentre pallidi spettri avvolti da sudari
Vanno d’attorno!
Dorme il mio amore! Oh, possa il suo sonno
Ch’è duraturo essere profondo!
E lievi i vermi le striscino dintorno!
Nella selva lontana, antica e oscura,
Possa un sepolcro per lei aprir le braccia –
Un sepolcro che spesso abbia richiuso
Le ali sue nere ed ondeggianti,
Trionfante, sulle stemmate insegne
Delle esequie dei suoi nobili avi –
Qualche remoto sepolcro, solitario
Contro il cui ingresso abbia – da bambina –
Lanciato sassi per divertimento –
Qualche sepolcro alla cui porta echeggiante
Mai più un’eco lei possa sottrarre,
Eccitata al pensiero – oh povera figliola del peccato!
Che quello fosse il gemito dei morti.
(C) 2013 by Francesca Diano RIPRODUZIONE RISERVATA
THE SLEEPER
At midnight, in the month of June,
I stand beneath the mystic moon.
An opiate vapor, dewy, dim,
Exhales from out her golden rim,
And, softly dripping, drop by drop,
Upon the quiet mountain top,
Steals drowsily and musically
Into the universal valley.
The rosemary nods upon the grave;
The lily lolls upon the wave;
Wrapping the fog about its breast,
The ruin molders into rest;
Looking like Lethe, see! the lake
A conscious slumber seems to take,
And would not, for the world, awake.
All Beauty sleeps!- and lo! where lies
Irene, with her Destinies!
O, lady bright! can it be right-
This window open to the night?
The wanton airs, from the tree-top,
Laughingly through the lattice drop-
The bodiless airs, a wizard rout,
Flit through thy chamber in and out,
And wave the curtain canopy
So fitfully- so fearfully-
Above the closed and fringed lid
‘Neath which thy slumb’ring soul lies hid,
That, o’er the floor and down the wall,
Like ghosts the shadows rise and fall!
Oh, lady dear, hast thou no fear?
Why and what art thou dreaming here?
Sure thou art come O’er far-off seas,
A wonder to these garden trees!
Strange is thy pallor! strange thy dress,
Strange, above all, thy length of tress,
And this all solemn silentness!
The lady sleeps! Oh, may her sleep,
Which is enduring, so be deep!
Heaven have her in its sacred keep!
This chamber changed for one more holy,
This bed for one more melancholy,
I pray to God that she may lie
For ever with unopened eye,
While the pale sheeted ghosts go by!
My love, she sleeps! Oh, may her sleep
As it is lasting, so be deep!
Soft may the worms about her creep!
Far in the forest, dim and old,
For her may some tall vault unfold-
Some vault that oft has flung its black
And winged panels fluttering back,
Triumphant, o’er the crested palls,
Of her grand family funerals-
Some sepulchre, remote, alone,
Against whose portal she hath thrown,
In childhood, many an idle stone-
Some tomb from out whose sounding door
She ne’er shall force an echo more,
Thrilling to think, poor child of sin!
It was the dead who groaned within.
16 Gen 2013 1 Commento
in Alois Riegl, Andrea Zanzotto, Anita Nair, arte, Arthur Schopenauer, Carlo Diano, carlo diano forma ed evento, case editrici, concorsi letterari, Cork, critica d'arte, Croker Diano, Diano Carlo, Diego Valeri, Edgar Allan Poe, fairy legends, filosofia, folklore, forma ed evento, Francesca Diano, Francesca Diano traduttrice, Franco Fortini, Franco Fortini traduttore, Grammatica storica delle arti figurative, Irlanda, lamentazione funebre, letteratura femminile, letteratura greca, londra, londra vittoriana, Nair Diano, Neri Pozza, Ninì Oreffice, Poe Francesca Diano, poesia, poeti italiani contemporanei, Premio Teramo, Riegl, scrittori italiani, Sergio Bettini, Simone Gambacorta, teoria della traduzione, Thomas Crofton Croker, tradizione orale, tradurre poesia, traduttore, traduzione letteraria, traduzione poetica, traduzioni, università di padova

Fra i miei due padri e Maestri, Sergio Bettini (a sinistra), Sergio Bettini e Carlo Diano. Università di Padova il giorno della mia laurea
| Riporto qui la bellissima intervista che gentilmente mi ha voluto fare Simone Gambacorta per il blog della Galaad Edizioni da lui curato. Ho conosciuto Gambacorta in occasione del Premio Teramo, che la Giuria ha generosamente voluto assegnarmi e per il quale svolge l’oneroso e complesso ruolo di segretario (vedi organizzatore, coordinatore, angelo alla cui vista nulla sfugge). Lo ringrazio per la sensibilità con cui ha saputo scegliere le domande, per nulla ovvie e per lo spazio che mi ha concesso. http://www.galaadedizioni.com/dblog/articolo.asp?articolo=471 |
| Francesca Diano ha vinto nel novembre 2012 la XLII edizione del Premio Teramo con il racconto “Le libellule”. Nata a Roma, si è trasferita a Padova quando ancora era piccolissima, aveva infatti appena due anni, a seguito del padre, il celebre grecista, filologo e filosofo Carlo Diano, che era stato chiamato a ricoprire la cattedra di Letteratura greca di Manara Valgimigli all’Università. Quando aveva dieci anni, Diego Valeri, colpito dalla sua scrittura, volle farle pubblicare delle poesie nella rivista «Padova e il suo territorio». Laureata in Storia della critica d’arte con Sergio Bettini, ha vissuto a Londra, dove ha lavorato al Courtauld Insitute e ha tenuto corsi di Storia dell’arte italiana all’Istituto Italiano di Cultura. In Irlanda ha invece insegnato all’University College di Cork. Ha anche tenuto corsi estivi in lingua inglese di Storia dell’arte Italiana all’Università per Stranieri di Perugia. Ha curato la prima traduzione in italiano, dal tedesco, della “Grammatica storica delle arti figurative” di Alois Riegl ed è stata la prima a tradurre in italiano “Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland”, di Thomas Crofton Croker, il primo testo di leggende orali sulle isole britanniche. È la traduttrice italiana delle opere della scrittrice indiana Anita Nair. In questa intervista Francesca Diano, che è anche autrice del romanzo “La Strega Bianca”, parla della traduzione, ma soprattutto racconta la sua storia, il suo percorso professionale, il suo amore per la cultura e per tutto ciò che è pensiero.Penso a suo padre, il grecista Carlo Diano, e le chiedo: che cosa significa nascere e vivere in un ambiente familare di per sé intriso di cultura? Che tipo di porosità comporta, tutto questo? E in che modo indirizza o ispira le scelte che, più avanti, si compiranno? «È una domanda a cui non saprei dare una risposta precisa, perché è come chiedere a un pesce cosa significhi nuotare nel mare, o a un uccello volare. Una cosa del tutto naturale. Se sei un pesce o un uccello, ovviamente. Ecco, il punto è questo. Si può essere immersi in un elemento che risponde alla tua natura – e questo è un dono della vita – oppure che non ti è congeniale e in questo caso l’ambiente non inciderà, oppure inciderà in senso negativo, per una sorta di rigetto. Per me è stato un grande privilegio – me ne sono resa conto solo quando tutto questo è finito – nascere figlia di quel padre, e ancora più fortunata mi ritengo per aver ereditato, assorbito. la sua sete di conoscenza. Il mondo in cui vivevo non era solo un ambiente intriso di letteratura ma – l’ho capito in seguito, confrontandomi con altre esperienze – una sorta di aristocrazia del pensiero, del meglio che il ‘900 abbia visto. E non solo in Italia, perché nella nostra casa arrivava un po’ tutto il mondo. Studiosi, filosofi, poeti, artisti, letterati, storici delle religioni, musicisti. Oltre a italiani, anche francesi, tedeschi, inglesi, svedesi, americani. La bambina che ero li guardava e li ascoltava con immensa curiosità. Ho avuto come padrino e madrina di battesimo Ettore Paratore e la sua bellissima moglie Augusta, nipote del grande Buonaiuti, che non è un cattivo esordio. Nella prima parte della mia vita sono vissuta in un mondo privilegiato, che a me pareva l’unico e in seguito l’impatto con altre realtà non è stato facile. Mi rendo conto che sono vissuta in un mondo scomparso, che se da una parte mi ha dato degli strumenti unici di approccio alla vita, dall’altra ora mi fa sentire come in esilio da una patria perduta. È un mondo che riesco a ritrovare però nei libri, nella gioia dello studio e della scrittura. E, forse perché ormai ho accumulato molti anni e molte vite, nel custodire quei ricordi. La stessa università di Padova raccoglieva contemporaneamente cervelli come mio padre, Sergio Bettini, Carlo Anti, Giuseppe Fiocco, dei Maestri che davvero hanno aperto nuove strade. Personalità come queste hanno lasciato un vuoto non più colmato. Poi c’era la sterminata biblioteca di mio padre, da cui mi hanno parlato secoli di sapere, da cui attingevo in modo disordinato e vorace. Ho letto libri come “Vita di Don Chisciotte” di Miguel de Unamuno, o “Delitto e castigo”, o “Iperione” di Hölderlin a undici, dodici anni. Capivo la metà di quello che leggevo, ma era proprio quello che non capivo che mi affascinava. In quella biblioteca di oltre 10.000 volumi, c’erano le letterature di tutti i tempi e di tutti i luoghi, e libri di filosofia, di arte, di critica, di scienze matematiche e naturali, di storia delle religioni, di teatro e molto altro e insomma era lo specchio della mente e del sapere di mio padre, che non è stato solo filosofo, grecista e filologo, ma anche pittore, scultore, poeta e compositore di musica. È stata la sua ecletticità che mi ha insegnato a essere curiosa di tutto, a non temere di esplorare campi non miei (se mai ho avuto dei campi miei), a inoltrarmi lungo vie ignote. Insomma, proprio come per le parti dei libri che non capivo, mi ha sempre attratto quello che non so. Non ho una mente accademica – e vedendo molti cosiddetti accademici di oggi la ritengo una cosa positiva – ma più di una curiosa, di un’innamorata del sapere. E questo è quello che di me più mi piace. Eppure, immersa in tutta questa sapienza e conoscenza, la lezione più grande che ho tratto da mio padre è stata di aver visto come tutto questo suo sterminato sapere non abbia mai soffocato in lui un’umanità traboccante, una generosità impetuosa e un’innocenza del cuore che ben pochi intellettuali possiedono. Spesso una mente cui si dà eccessivo spazio invade ogni altro campo della vita e soffoca e inaridisce il cuore. La sua mente era mossa dal cuore e non l’opposto. Sì, direi che è stato questo l’insegnamento più grande. Mio padre si è sposato piuttosto tardi e quando è morto avevo ventisei anni e già da tempo vivevo lontana. Spesso mi chiedo quanto sarebbe stato importante averlo accanto più a lungo, quanto ancora avrei imparato – ormai adulta – da lui, che dialoghi ricchissimi avremmo potuto fare. E quanto mi sarebbe stato preziosa la sua presenza in momenti difficili della mia vita. Ma ci sono le sue opere e, leggendo i suoi scritti e le sue carte, anche inedite, quel dialogo e quella vicinanza esistono comunque, pur se in modo diverso» .Nella sua vita la poesia è arrivata molto presto, e nel nome di Diego Valeri… .Come storica dell’arte – il suo maestro è stato appunto Sergio Bettini – ha insegnato in Inghilterra e in Irlanda. Se non sbaglio, è nella storia dell’arte che trova inizio la sua attività di traduttrice: penso infatti alla traduzione dal tedesco della “Grammatica storica delle arti figurative” di Alois Riegl, che lei ha realizzato nel 1983 per l’editore Cappelli, firmando anche le pagine introduttive e gli apparati di note. A proposito di quella traduzione, che le valse anche una menzione speciale al Premio Monselice, vorrei porle due domande. Cominciamo dalla prima: che cosa ha significato, e che lavoro ha richiesto, affrontare un’opera così complessa e tecnica? L’altra domanda è invece questa: qual è il valore culturale, nell’ambito della storia dell’arte, dell’opera di Riegl? Uno dei suoi campi di studio è quello delle folklore e della tradizione orale irlandese. Com’è nato questo amore? Che rapporto ha stabilito con “quella” copia di Croker? Ma che cosa è “diventato” per lei Thomas Crofton Croker? La traduzione italiana dell’opera ha avuto molto successo… Quali sono le differenze tra la traduzione di un’opera saggistica e la traduzione di un’opera letteraria? Lei è anche la traduttrice della scrittrice indiana Anita Nair. Che cosa significa attraversare e ricreare le pagine di un’autrice che appartiene a un’area culturale completamente diversa? Torniamo a quanto abbiamo detto: dietro le quinte di una traduzione c’è un vero e proprio percorso di studio… Fra gli altri, lei ha tradotto Kushwant Singh, Themina Durrani, Pico Iyer, Susan Vreeland, Sudhir Kakar, Uzma Khan. Quali sono gli autori, fra quelli che ha tradotto, che sente più suoi? Quando deve tradurre un libro, quali sono le fasi che scandiscono il suo lavoro? Giorgio Caproni diceva che tradurre equivale a «doppiare». Lei che cosa ne pensa? Un autore che vorrebbe tradurre? Un traduttore che ammira? Un traduttore o una traduzione che considera sopravvalutati? Senta, ma se lei dovesse spiegare in parole estremamente semplici che cosa vuol dire tradurre, che cosa direbbe? E se dovesse spiegare qual è il bello del lavoro del traduttore? (C)2012 by Simone Gambacorta e Francesca Diano TUTTI I DIRITTI RISERVATI |
Commenti recenti