

- Carlo Diano a Bressanone
Carlo Diano è stato un esiliato tutta la sua vita.
Da questo forse derivava quel suo carattere così fatto di contrasti. L’estrema dolcezza si alternava a momenti in cui la sua mente si allontanava, persa nelle sue speculazioni, per passare all’improvviso ad esplosioni di insofferenza o di ribellione. Il tutto senza soluzione di continuità e senza che vi fosse preavviso di quei cambiamenti.
Dell’esiliato mio padre aveva l’irrequietezza, come di chi viva tutta la vita col dolore di una perdita, di un vuoto incolmabile, che nulla potrà mai colmare, perché ciò che potrebbe colmare quel vuoto è perso per sempre. E di questo v’è consapevolezza.
Esiliato da dove? O da cosa?
A otto anni era rimasto orfano del padre, capostazione a Vibo Valentia, che allora si chiamava Monteleone di Calabria.
Era il primo di quattro tra fratelli e sorelle (altri due erano morti bambini) e sua madre si trovò improvvisamente vedova e senza mezzi. Nella famiglia di sua madre c’erano medici e notai, ma nella Calabria di inizi ‘900, a parte la solidarietà delle sue sorelle, mia nonna si trovò a fronteggiare fatiche e sacrificio nel crescere i figli.
Quasi da sola dovette affrontare difficoltà economiche, mancanza di un sostegno, enormi responsabilità nel crescerli quei quattro figli.
L’infanzia di mio padre deve essere stata molto dura e difatti non ne parlava mai, come se quegli anni tanto difficili gli avessero lasciato dentro un nodo oscuro, che non era nemmeno in grado di ricordare perché così crudele. Il ricordo di un tradimento. Di un abbandono. Come figlio di suo padre e come figlio della propria terra. E dunque, chi è in esilio così dalle proprie radici, può andare ovunque, perché ovunque sarà in esilio, ché se lo porta dentro. Perché in realtà è in esilio da se stesso.
Per quanti legami possa stringere nel suo vagare, nessun legame lo strapperà alla sua solitudine assoluta. E allora, l’unico dialogo vero, autentico, profondo, può essere solo quello con la propria solitudine, che altro non è se non la scissione dolorante e dolorosa dalla patria interiore: da se stesso. Da un se stesso che si è dovuto autogenerare.
E’ questa però la condizione ideale per la creatività, come se gli occhi dell’anima, rivolti costantemente verso l’interno, attingessero alla fonte della solitudine, per creare, per capire il mondo e darne un’immagine.
Quale fosse una parte della sua patria perduta mio padre lo capì molto presto: lo capì attraverso Carlo Felice Crispo, un vibonese di famiglia aristocratica, che aveva dedicato la sua vita agli studi e alla speculazione, e che come lui si portava dentro la piaga di una separazione non sanabile. Crispo esiliato dal sogno degli Orfici. Mio padre dagli assoluti delle forme che vedeva con occhi antichi dentro di sé, prima ancora che fuori. Ma per entrambi, il luogo e il tempo a cui tornare erano scomparsi due millenni e mezzo prima. E non sarebbero tornati mai più.
Con la Calabria aveva un rapporto conflittuale. Ne era partito a poco più di diciassette anni quando, dopo la maturità classica, era andato a Roma a studiare all’università.
I soldi per il viaggio gli erano stati dati da una zia, sorella di sua madre e da Roma scriveva a casa lettere piene di nostalgia e dolore. Chiedeva che gli mandassero l’origano, le olive, i sapori e gli odori della sua terra. Perché una parte della sua casa, del suo mondo, a cui era legato non solo dalla sofferenza, ma dalle prime scoperte di se stesso e della sua vocazione, dagli affetti della famiglia e dai paesaggi incantati, fosse presente nella quotidianità dura della sua nuova realtà.
Chiedeva, con la sete della lontananza e con il desiderio di mantenere un legame con le cose note. In una realtà che era per lui ancora ostile e ignota. Dove era e si sentiva solo. E in alcune di queste lettere, a sua madre, ai suoi fratelli, trapela tra le righe il carattere di un mistico, di chi ha fatto già del dolore uno strumento di conoscenza.
Amava gli ulivi. Si era portato dentro la loro forma contorta e viva per tutta la vita. Perché l’ulivo non era solo l’albero della sua terra, ma è la prova vivente della capacità di sopravvivere ad ogni tempesta, ad ogni fulmine, ad ogni trascorrer del tempo che uccide la bellezza. Perché nell’ulivo il tempo è bellezza, e ne modella la forma segnandola di sé. L’ulivo è la prova vivente che la sofferenza può essere anche fonte di nutrimento e di vita. E all’ulivo aveva dedicato molti dei suoi disegni e il distico che scrisse in occasione dello scempio della Piana di Gioia Tauro.
La sua terra era la sua radice, perché lì aveva scoperto per la prima volta la bellezza degli antichi padri magnogreci, anche grazie all’incontro con quell’uomo straordinario, appunto, Carlo Felice Crispo, per il quale scrisse una bellissima commemorazione, quando Crispo morì a Roma, ucciso dallo stesso male di Epicuro. E che, come Epicuro, aveva sopportato con coraggio e nobiltà.
Crispo gli aveva reso vive le matrici greche della loro terra comune.
Mio padre non lo avrebbe mai dimenticato.
Ma da quella terra di antichi padri era dovuto partire, per affrontare da solo e così giovane un mondo che non gli era facile affrontare.
Una volta, che io avevo circa l’età in cui lui era andato a Roma, facemmo un viaggio insieme. Io e lui, a Roma. E una sera, andando al teatro Argentina, passammo davanti a un torracchione scrostato e lasciato ancora intatto dal tempo. Alto, triste, gelido.
<<Quando sono venuto a Roma la prima volta, ho abitato lì sopra>>, mi disse. Lo disse come diceva le cose che gli risvegliavano vecchie sofferenze. Per le quali non ci sono parole. Lo disse quasi casualmente, quasi sottovoce. Non disse altro. E allora mi resi conto per la prima volta, guardando mio padre come quel ragazzino di allora, di quanto dovesse aver sofferto. La fame, il freddo, la solitudine. E per la prima volta cominciai a capire. Il suo desiderio di non farci mai mancare nulla, di aiutare sempre i giovani e chi si trovava in difficoltà, il silenzio sulla sua giovinezza, i suoi sbalzi d’umore. La sua fame di vita.
In un quadernetto a righe, datato 1918-25, aveva raccolto alcune poesie che poi, in parte, aveva pubblicato nel 1933 col titolo “L’acqua del tempo”. Ce n’è una, inedita, in forma di sonetto, che non aveva incluso nella raccolta e che sopra reca il segno di una cancellatura, forse perché gli era parsa troppo cruda, che invece esprime con una chiarezza di lama acuminata lo stato d’animo di quanto ho appena detto.
Io ti conobbi, tazza avvelenata
del disinganno, assai volte ed ancora,
sempre più amara e pur t’ho tracannata
lentamente, qual chi vino assapora.
Del tuo velen sottile ebbi malata
l’anima ed aborii veder l’aurora
prossima, e terminai la mia giornata
maledicendo attediato ogni ora.
E vissi e il tempo, nel suo molle volo
spense ogni grido,chiuse ogni ferita
e recò l’ombra di sogni novelli.
Or tu ritorni e m’aggredisci solo
quando l’ultima speme è disfiorita
e vizzo è il fiore dei miei dì più belli.
L’amarezza del disinganno sarebbe stata il leit-motiv della sua vita. Una lezione che si sarebbe ripetuta in molti dei suoi rapporti con gli altri esseri umani.
La sua era una natura in fondo ottimista e facilmente entusiasmabile, non sembri troppo facile dire “ingenua” e dunque questa sua natura lo portava non tanto a fidarsi degli altri, quanto ad affidarsi agli altri.
Se la fiducia nel prossimo è una virtù, il porre nelle mani altrui il proprio benessere, la propria serenità, la propria felicità, è un grande errore. Eppure, ad ogni disinganno, come già poco più che ragazzo aveva capito, tracannava, con coraggio. Fino in fondo.
Lo ha fatto tutta la sua vita. Quando sfidò il potere, giovane docente di Greco al Liceo Tasso di Roma, rifiutandosi di iscriversi al Parito Fascista, come gli era stata fatta pressione, quando compì scelte che solo un pazzo sognatore avrebbe potuto compiere, sposando delle cause ormai perse e abbandonate da tutti, che gli costarono per anni la carriera, quando mise in salvo, all’insaputa di tutti ancora oggi, molta gente ricercata dalla Gestapo a Padova, grazie al suo ruolo di Ispettore della Pubblica Istruzione, ( e nessuno ne ha fatto un eroe per questo) quando si fidò di chi non doveva fidarsi, solo per coerenza con le proprie idee. Quando giunse a mettere in palio la vita per rendere pubblicamente omaggio al suo Maestro, Giovanni Gentile, che era stato per lui il padre che non aveva avuto ed era stato assassinato in modo vile. Per commemorarlo nonostante le minacce di morte che gli erano giunte da più parti.
Era capace di un amore senza pudori quando trovava un uguale, chi sapesse parlare alla sua anima, abbattendo le barriere tra essere e essere. Così fu per Giovanni Gentile, per Giorgio Pasquali, per Ugo Spirito, per Walter F. Otto, per Mircea Eliade, per Sergio Bettini. Uomini che hanno segnato la sua vita e la sua mente. Come Maestri e come amici. Uomini a cui lo legavano percorsi di conoscenza e di affetto.
Aveva, dell’amicizia, la stessa concezione di Epicuro. Non conosceva felicità più grande del trovarsi con animi affini. Non solo del presente, ma del passato. Discorreva con Parmenide e con Platone, con Epicuro, con Leopardi e con Baudelaire come con i suoi Maestri e i suoi amici. Senza barriere. Né di tempo né di spazio.
Ma la malattia dell’anima che lo ha minato tutta la vita e che, ne sono convinta, è stata la causa del suo infarto prima e del suo cancro poi, questo “velen sottile”, era da ricercarsi proprio nei primi tradimenti della vita, quelli che, se ti segnano troppo presto, non sono facilmente sanabili.
La cura che lui aveva trovato per sé, perché in questi casi si sopravvive solo trovandosi dentro i meandri dell’anima una cura, era il viaggio dello spirito verso un mondo perduto. La Grecia nei suoi studi e nella mappa della sua anima, giunta a lui, intatta dal passato, attraverso la nascita in una terra colonizzata da quegli antichi esuli volontari.
Ma gli ultimi tre versi del sonetto sembrano essere una terribile premonizione di quella che sarebbe stata la conclusione della sua vita. Il ritorno di quel veleno che lo avrebbe aggredito alla fine.
I poeti hanno il dono della premonizione.
La Calabria era per lui una terra trasfigurata. Era la Calabria della sua fanciullezza, in cui andava a cogliere i fichi d’India dalle piante e saliva sugli ulivi e sugli alberi di fico e una volta una spina gli aveva procurato un’infezione a un mignolo, che gli aveva lasciato una cicatrice che gli teneva piegata la falange. Quel segno era in fondo il ricordo delle sue scorribande felici di ragazzo nelle campagne, ma anche il ricordo di una ferita mai guarita. Cicatrizzata, ma malamente.
Così era per lui la Calabria. Una ferita cicatrizzata, ma malamente.
E dunque, andare in Calabria, per lui, era come riaprire la vecchia ferita. Quella della perdita, quella dell’assenza. Non ci andava a cuor leggero e aveva coi suoi abitanti un rapporto conflittuale, quasi infantile. Come di chi si sia sentito tradito.
Ma dalla Calabria in cui era nato – non per caso – come mai per caso qualcosa avviene – aveva anche ricevuto una doppia eredità, dalle due stirpi che vi hanno lasciato il loro segno: i Greci e i Normanni. La mediterraneità e il richiamo delle terre del grande nord. E non a caso difatti, in lui la grecità si mischiava con l’amore per il Nord Europa e per la Scandinavia, una terra in cui aveva vissuto per sei anni e dove, per contrasto, aveva forse ritrovato parte di se stesso.
Il suo aspetto, del resto, era quello della lunare stirpe normanna, da cui la famiglia paterna derivava. Di struttura robusta, i capelli biondi in gioventù, somigliava poi sempre più con l’età a Jean Gabin o a Spencer Tracy, di cui aveva anche lo sguardo ironico e dolce. Con un fondo di malinconia che non lo abbandonava mai.
Ma la vera patria da cui si sentiva in esilio era la Grecia.
Non so se ne avesse piena percezione. Di quanto quell’amore fosse mischiato allo struggimento e alla nostalgia di un esilio e di come, rendendo viva dentro di sé quella cultura e parlandone come ne fosse appena tornato, di fatto si comportasse come si comporta un esule, che conserva intatta dentro di sé l’immagine della sua terra d’origine.
In realtà non era un uomo ne’ di questo tempo ne’ di questo luogo.
Era come piovuto qui, intatto dal passato, e come tale non poteva essere compreso.
Lui vedeva quelle forme con gli occhi di un uomo di venticinque secoli fa. Quei testi, morti sulla carta, a lui parlavano con una voce fresca, bisbigliante, la stessa di venticinque secoli fa. Comprendeva perché conosceva. Perché sapeva. Già – dentro di sé.
Dagli altri, da quelli del suo tempo, era separato da un muro invisibile ma invalicabile. Sia in un senso che nell’altro. Ed era un privilegio e una condanna.
Aveva questa singolare percezione del tempo. Non viveva mai nel presente, perché o la sua mente era persa nella visione abbacinante del passato, o proiettata in avanti alla velocità del fulmine. Per lampi. Comprendeva prima ancora di aver capito. Eppure mai ho visto qualcuno più capace di amare l’istante.
Non sopportava di non essere amato. Perché la ferita antica non s’era chiusa affatto e i sogni novelli, appunto, in lui forse erano solo ombra, come ebbe a intuire.
Non accettava di non sentirsi amato. E quando si rendeva conto che a volte non lo era, dentro di lui scoppiava la disperazione e forse l’angoscia. Vecchie ferite si riaprivano, l’eco di antichi abbandoni, di antiche insicurezze riaffioravano alla superficie con prepotenza. E reagiva alternativamente in modo aggressivo o infantile, ma sempre chiedendo amore e attenzione.
Era un uomo apparentemente di sentimenti estremi. Eppure era capace di incredibili tenerezze, di delicatezze commoventi. In apparenza era poco psicologo, e invece non sbagliava mai un giudizio. Solo che i suoi giudizi anticipavano i tempi e di molto. Così tanto, che non li si potevano verificare se non in un futuro distante. Sempre precisi a tal punto, che l’avresti detto un veggente. Ma era il veggente come lo intende Baudelaire, un poeta che amava tanto da tenersene un ritratto nello studio.
Non posso dimenticare quando, il giorno successivo alla strage di Piazza Fontana, quando la stagione oscura degli anni di piombo si affacciava a proiettare un’ombra sinistra sulla storia del notro infelice paese, mio padre disse: “Sono stati loro“. Gli chiesi cosa intendesse con “loro”. E la sua risposta, che allora era apparsa del tutto improbabile fu: “Quelli che ci governano”. Ma morì nel 1974, molto prima che tutto questo fosse chiaro.
L’aveva capito con l’anticipo di decenni. Noi lo sappiamo solo ora, dopo anni di processi che hanno umiliato la Giustizia. Quella con la G maiuscola. Quella in cui credeva Socrate, tanto da dare la vita.
Come poteva essere davvero capito? Sentirsi tra simili?
Aveva il dono dell’essenzialità e della sintesi. Ogni sua pagina è un condensato di idee, intuizioni, analisi profonde e acutissime, illuminazioni per lampi. Non diluiva. E dunque ogni sua pagina è una quintessenza, un distillato, che a voler essere compreso va diluito in cento almeno. E’ questa la difficoltà che pone la lettura dei suoi scritti. Limpidi, chiarissimi, ma densi come una sostanza densa.
Altri avrebbero costruito una carriera sul materiale di una sua sola conferenza. Perché anche in questo dava. Dava di sé senza risparmio.
Dunque anche le sue opere devono ancora essere comprese veramente. C’è ancora tutto da fare.
Sarà un lavoro lungo, per chi verrà dopo di lui.
Quel che lascia un uomo dietro di sé, nei suoi scritti, nelle sue opere, non va giudicato attraverso lo specchio di quella che è stata la vicenda della sua vita. Ecco perché chi viene dopo comprende meglio dei contemporanei. Perché nel suo giudizio non si lascia fuorviare dallo specchio deformante del rapporto emotivo.
Ma a volte è giusto rendere giustizia. Quando le azioni di un uomo, dettate dalla coerenza con se stesso, possono essere velate e nascoste nel loro impulso puro e profondo dalla fragilità nata dalla sofferenza. E la superficialità del giudizio comune non ha gli strumenti per comprendere i moti di un’anima.
Il carattere generoso e impetuoso, ma a volte in apparenza prepotente di mio padre, era solo il prodotto di sofferenze taciute con pudore, di vuoti non colmabili, del senso di isolamento in un mondo lontano dal suo mondo interiore.
Ha vissuto in modo tragico. Non nel senso scontato del termine, ma perché misurandosi costantemente col suo demone, lottando costantemente con l’ombra dentro di sé.
Un’ombra potente, che in apparenza lo ha sconfitto nel corpo.
In apparenza.
Ma le sconfitte sono spesso più onorevoli di una vittoria, quando sai che, in fondo alla tua lotta, ti attende solo la sconfitta. Ma non rinunci a combattere con coraggio. Sia pure contro la morte.
Credo che, a conclusione di questo mio tentativo di capire mio padre, non da figlia, ma da persona che ha vissuto e cercato di capire il mondo intorno a sé, un tentativo non so quanto riuscito, ma fatto con lo strumento dell’amore (non potrei usarne altri, perché è il cuore che conosce e non la mente) l’ultima parola spetti a lui. A lui con linguaggio di poeta, l’unico, insieme alla musica, capace di rivelare l’ineffabile. E difatti mio padre ha lasciato anche della meravigliosa musica da lui composta. Con la poesia che io giudico più intensa e rivelatrice che abbia scritto. Quando era ancora molto giovane, ma molto già aveva compreso.
Una poesia quasi leopardiana, poiché tanto amava Leopardi, un altro esiliato come lui. Del Leopardi de L’Infinito, testo che anche potrebbe a ben ragione recare il titolo di “Atman”, come quello che scelse mio padre.
ATMAN
Ho paura del silenzio della notte
e mi sento abbandonato da ogni cosa
e dinanzi agli occhi ho l’ombra del mio cuore
coi suoi mille desideri senza nome,
cui non basta il mondo, che oltre il mondo vanno
e più forti sono della stessa morte;
ed il vuoto sento intorno a quest’oscuro
mio volere, incomprensibile, solingo,
e mi par di non poter più ripigliare
la mia vita, non poterla più finire,
ma restare per l’eterno condannato,
vuota brama, nel mio nulla imperituro.
Mio padre, Carlo Diano. Giornata di studi per la commemorazione di Carlo Diano nel centenario della nascita. Padova, 2002
___________________________________________
Questo è il padre che io ho conosciuto, ma poi c’è Carlo Diano, lo studioso assetato di conoscenza, il docente universitario che ha cambiato la vita a molti che lo hanno avuto come Maestro, il filosofo rivoluzionario, il pensatore originale che ha percorso vie inesplorate, e il filologo tra i più grandi del ‘900.
Il pensiero di mio padre nell’interpretazione del mondo greco, ha aperto una strada che molti hanno percorso. Ma, come ha detto Massimo Cacciari nella giornata di studi tenuta all’Università di Padova nel 2002 a commemorazione del centenario della sua nascita, Carlo Diano è stato un outsider non solo nel panorama del pensiero italiano del ‘900, ma europeo. L’originalità della sua visione ha avuto radice nella vastità della sua cultura, nell’ampiezza e nella libertà davvero rinascimentale della sua visione e in una capacità di sintesi e di intuizione solidamente fondate su un rigore filologico di qualità unica, basi di un pensiero filosofico ed estetico nuovo ed originale.
I suoi studi epicurei, la sua conoscenza di Platone, di Aristotele, dei presocratici, dei tragici greci, la sua convinzione che Parmenide e Anassagora siano alla radice del pensiero occidentale moderno, la creazione delle categorie di forma ed evento, che gli hanno permesso un’ interpretazione originalissima dell’arte e della cultura greca e la loro applicazione ad ogni epoca e ad ogni tempo, con risultati ancora insuperati e ancora tutti da esplorare, che solo ora iniziano da parte di alcuni studiosi ad essere esplorati e scoperti, hanno fatto di Carlo Diano uno dei maggiori pensatori del secolo passato.
Eppure…. su di lui la cultura italiana ancora tace, a parte alcune felici eccezioni, che ne tengono vivo il pensiero e l’insegnamento. Primo fra tutti, Massimo Cacciari, che non omette mai di menzionare, quando tiene quelle sue meravigliose conferenze, o quando scrive, che moltissimo di quello che è e fa lo deve al suo Maestro, Carlo Diano. Ma, a lui si è aggiunto di recente il grande filosofo della scienza Silvano Tagliagambe, che in rivoluzionari saggi ha dimostrato come il pensiero di Diano sia all’avanguardia ancora oggi.
Il silenzio degli altri non è un silenzio fatto di dimenticanza. Non era comunista, non era di sinistra, come andava di moda, e nemmeno di destra; era un uomo libero. Il suo solo partito era quello del Sapere. Non si è mai fatto comprare o sedurre dal potere corrente e non amava chi lo faceva. Non amava le chiesucole, le conventicole, i partitelli. Non amava gli eruditi sterili, incapaci di usare le loro nozioni vaste e inutili se non come un muro di fumo. Né gli imbonitori. Disdegnava le vie già percorse e i sentieri battuti. Le sole vie che amava erano quelle sconosciute.
Fa grande onore all’Università di Padova che vi sia un suo busto in bronzo, e una strada della stessa città che reca il suo nome e, a Vibo Valentia, la piazza della casa in cui nacque, a lui intitolata. Ma, a parte Boringhieri, che ha ristampato quella geniale storia della filosofia greca che è “Il pensiero greco da Anassimandro agli stoici”, per la cui introduzione Cacciari ha scritto le pagine più belle sul pensiero di Diano e la Lorenzo Valla, che seguita a ristampare nuove edizioni della sua meravigliosa traduzione dei Frammenti di Eraclito, e gli Scritti Morali di Epicuro pubblicati nella BUR, molti sono stati i progetti di ristampare le sue opere filosofiche ormai introvabili sul mercato, tanto che ne circolano versioni in fotocopia, ma ancora nulla è stato fatto. Eppure, so che si farà.
Aggiornamento del 2017
Nel frattempo sono state scritte tesi di laurea sul suo pensiero, giovani ricercatori iniziano a interessarsi dei suoi studi. Prossimamente negli USA uscirà una traduzione inglese di Forma ed Evento (dopo quella francese, spagnola e neogreca) per i tipi della Fordham University Press, poiché alcuni brillanti studiosi americani si sono innamorati di questo pensatore e, allo stesso tempo, non riescono a credere che in Italia le sue opere non si trovino.
Ma verrà il tempo in cui le cose saranno mature. Sarà quello il tempo giusto.
Francesca Diano
Voce Carlo Diano Wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Diano
(C) RIPRODUZIONE RISERVATA












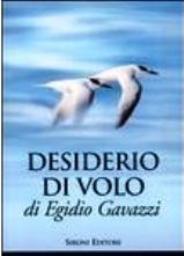




Commenti recenti