Acqua alta
da Fiabe d’amor crudele, Edizioni La Gru, 2013
La luce grigiastra gioca a rimpiattino con il respiro dell’acqua sotto il ponte delle Guglie. Un’ondina un riflesso, un riflesso un’ondina. La pioggia si diverte a trafiggere le ondine. L’odore forte di freschin annuncia scirocco ed è giugno.
Non è periodo di acqua alta, ma quando ieri mattina è iniziato a piovere ed è seguitato per tutta la giornata ed è continuato a piovere per tutta la notte e ancora nel corso della mattinata non ha accennato a smettere, l’acqua è presa a salire contro ogni previsione. Al punto che anche zone raramente invase dall’acqua alta ne vengono sommerse.
La sirena ha diffuso in tutta la città il suo suono inquietante dall’eco un po’ sinistra e con l’alta marea il canale sotto l’arcata panciuta del ponte arriva a lambire i muri delle case, cancellando sul rio ogni separazione tra mare e mura.
È un’ostinata pioggia autunnale fuori tempo travestita da temporale estivo. Qui anche la pioggia è in maschera.
Se, appena dove il ponte delle Guglie plana sulla salizada, si volta a sinistra, a metà del rio, sulla destra, si apre il portichetto che immette in Ghetto. Un piccolo vòlto che reca ancora i segni dei cardini su cui era imperniata la porta da chiudersi al tramonto e aprirsi all’alba. Così, per secoli, fino all’arrivo dei napoleonici che, fedeli ai principi egualitari della Rivoluzione, divelsero quel vergognoso ricordo di una separazione, non tanto degli ebrei dai bravi cristiani, ma dei bravi cristiani dagli ebrei.
Subito sotto il vòlto c’è la calle stretta su cui si apre il forno kasher. Tutti quei dolcetti di mandorle, quei pani azzimi, quelle tortine zuccherose ordinati in montagnole nella minuscola vetrina, vengono disposti ogni giorno come un baluardo di sapori contro la dimenticanza.
A fondale della calle, la facciata solenne della Schola Spagnola, quasi accudita dagli altissimi edifici a molti piani, fa da prologo alle bellezze che si celano dietro la curva a gomito. In Ghetto ormai si sente parlare molto di frequente angloamericano e americani sono i negozietti e le piccole botteghe di souvenir ebraici e americano è il libraio antiquario. In Ghetto si è ben radicata da qualche anno una comunità chassidica Chabad-Lubavitch, proveniente dagli USA. New York, per essere più precisi.
I Lubavitcher, con i loro severi cappotti e cappelli neri a larga tesa, le loro barbe fluenti o, per gli studenti chassidici, le semplici camicie bianche portate con pantaloni neri come una divisa, hanno recato un certo scompiglio nella vecchia comunità ebraica del Ghetto, che li osserva con scarsa simpatia. Ma è suggestivo vederli camminare in campo o mangiare seduti ai tavoli posti sull’orlo del canale davanti al ristorante kasher, in tavolate che si animano nelle discussioni e nel buon cibo ortodosso.
Giovanni è appena sceso dal treno, che è arrivato in forte ritardo. E non ha con sé stivali di gomma. Esce dalla stazione, svolta a sinistra, in Strada Nuova verso il ponte delle Guglie. È molto cambiato il Ghetto da quando ancora abitava lì vicino con sua madre. L’arrivo dagli USA della nuova comunità lo aveva molto incuriosito. Un amico che insegna ebraico a Ca’ Foscari gli ha raccontato del pensiero Chabad-Lubavitch, dell’origine del movimento, del fondatore, il rebbe Shneur Zalman di Liadi e delle tradizioni su cui si fonda la comunità. Il misticismo del pensiero del rebbe unito alla sua profonda conoscenza dell’animo umano, la sua capacità di definire la felicità e il suo raggiungimento attraverso l’unione col divino l’aveva catturato.
La pioggia sta diventando più battente. Nemmeno l’ombrello.
Scavalcando la barriera per l’acqua alta messa a guardia dell’ingresso, entra in una piccola valigeria dove, come quasi ovunque a Venezia, sono esposti ombrelli e stivaloni di gomma. Si toglie i mocassini zuppi – camoscio beige, cuciti a mano, figurarsi! – e infila i piedi in un paio di stivali di gomma verde che gli arrivavano alle ginocchia. Compra anche un ombrello ed esce, certo di essersi attrezzato per quella specie di monsone. Ora la pioggia si è infittita.
Il cellulare squilla. Ombrello, sacchetto del negozio, è Gregorio, di sicuro. Annaspando con le dita riesce ad aprire la tasca della sahariana di lino e ad afferrare il cellulare.
<<Dove sei!>> la voce di Gregorio ride e comanda.
<<Guarda Orio, qui c’è il monsone!>>
<<Ma dove sei? Sotto la doccia? Sento lo scroscio>>, gli chiede. <<E per l’amor di dio non chiamarmi con questo ridicolo diminutivo!>>
<<Per l’acqua che sta venendo giù potrebbe essere. Il fatto è che sale anche da sotto. Sono a Venezia e c’è l’acqua alta.>> L’ombrello si piega sotto le raffiche, il sacchetto rischia di cadergli di mano. <<Non posso certo chiamarti Greg. È orribile e snob. E se ti chiamo tutto intero metà di te è già scappato.>>
<<Ti voglio bene>>, dice Gregorio col tono brusco che emerge quando i sentimenti gli sfuggono dalla gola.
<<Anche io>>, risponde Giovanni. <<Quando ti vedo?>>
<<Appena posso. Credo presto.>>
<<Credi? Lo dici ogni volta. Io…>>
<<Domani ho il volo per New York, lo sai. Appena torno corro da te.>>
<<Già. Lo so. Viene a New York anche tua moglie?>>
<<Smettila con questa gelosia. Lo sai come stanno le cose.>>
<<Già… come stanno Orio? Ci sentiamo dopo? Qui diluvia e non so come arriverò da mia madre. E devo stare attento a non cadere in canale. Con l’acqua alta non si capisce più dove finisca la strada e dove inizi il canale. Ciao a dopo.>>
Clic. Non gli dà nemmeno il tempo di replicare al saluto.
<<Non potremo vederci spesso>>, gli aveva detto fin dall’inizio. <<Lo sai il lavoro che faccio. E poi, per quanto ti ami, sono sposato. Mia moglie non sa niente. Sarebbe distrutta se lo capisse.>>
<<Capisse che cosa? Che ti piacciono gli uomini? Che sei frocio?>>
<<Non usare quella parola orrenda! Sei tu che non puoi capire. O non vuoi.>>
<<Sì, non sono sposato. Non so come ci si senta.>>
<<Ma non possiamo essere felici anche così?>> aveva chiesto Gregorio.
In effetti non gli era parsa una difficoltà insormontabile. All’inizio. La passione non lasciava spazio a ragionamenti o prospettive. Sapere che Gregorio correva, in fondo, dei rischi per vederlo lo aveva esaltato. Ora però, dopo mesi passati attaccato a una voce che emergeva dallo sfondo di diversi medley sonori e gli incontri brevi, intensi – è vero – come battaglie campali, la situazione ha iniziato a creargli un disagio che sta crescendo come l’acqua del canale.
A volte prova un senso di soffocamento. Gregorio comincia a farlo sentire in trappola.
<<Io sono un uomo libero, non sopporto costrizioni>>, gli ripete quando si vedono. <<Solo quelle dell’amore>>, ci aggiunge poi guardandolo con uno sguardo liquido.
<<Ma l’amore non è una costrizione!>>, ribatte Giovanni. <<Se lo si vive così è un inferno. E poi, di che libertà parli? Non sei nemmeno capace di essere quello che sei davvero.>>
<<Ma io lo sono, con te.>>
<<Non sei stufo di tutte queste bugie? Di questa vita a metà?>> Giovanni non riesce a trattenersi.
<<E’ facile per te dirlo>>, ribatte Gregorio, <<tu non hai il problema di doverti nascondere.>>
<<Il problema, come lo chiami, ha avvelenato molti anni della mia vita. Ma tu lo sai quello che mi è costato uscire allo scoperto? Lo sai le sofferenze, gli orrori che ho dovuto guardare in faccia? Gli sguardi della gente, i giudizi, l’espressione di ripugnanza negli occhi di mio padre?>>
Gli impone qualcosa che comincia a non volere più. Ha la sensazione di essersi lasciato avvolgere di nuovo da fili robusti e invisibili che l’hanno immobilizzato in una gabbia di illusioni. Si sente risucchiato verso un luogo oscuro che credeva non esistesse più dentro di lui. Non sa se ce la farà a liberarsene.
Prosegue cauto lungo i muri, per essere certo di non cadere in canale. Dove sta il confine? Il bordo della strada è sott’acqua; non lo si può distinguere. Il bordo oltre il quale il canale ti inghiotte. Basta poco. Tutto è incerto.
Quella che Gregorio chiama libertà è in realtà la prigione imposta a un altro. La sua. Giovanni non ha scelto quell’incertezza per permettere a lui la certezza del disimpegno. Non è facile, no. Ma non è autentico.
Mentre dall’alto le raffiche di vento cariche di pioggia gli frustano la faccia – l’ombrello è ormai inservibile, non lo ripara da nulla – e gli inzuppano i capelli, dal basso l’acqua comincia a entrare negli stivali. Scic sciac fanno i suoi passi, rallentati dal peso scivoloso. Un’esplosione di infelicità gli fa mancare il respiro. Gli viene da piangere. Poi sorride, perché le lacrime non possono nemmeno essere se stesse fra i rivoli d’acqua che gli bagnano il viso. Non le si saprebbe nemmeno distinguere. Una frustata di vento più forte delle altre gli strappa l’ombrello e lo scaglia in canale. La corrente lo trascina via con leggerezza.
Un canto, così sonoro da sovrastare il ruggito del vento, misto a risate a piena gola gli arriva alle orecchie del tutto inatteso. Quasi fuori luogo.
Dal vòlto che immette in Ghetto, che è completamente allagato dall’acqua, ormai indistinguibile dal livello del canale, spunta una forma panciuta di lucida plastica arancione. Il canto, in una lingua che non capisce – forse yiddish – interrotto continuamente da scoppi di risa, proviene da lì. Nel grigiore delle pietre di Venezia, del cielo e nel viscidume verde dell’acqua, una forma panciuta emerge ondeggiando dall’arco di granito, reso liscio dai secoli, trascinata e cullata dall’acqua nella direzione del canale. È un grande canotto gonfiabile di forma rotonda, di quelli che i bambini usano al mare d’estate, i fianchi lucenti decorati da disegni di pesci e stelle marine multicolore. Su di un lato svetta, come sull’Isola Che Non C’È, un’assurda palma di plastica, il cui tronco rigonfio e le cui foglie di pvc verde si agitano sotto la forza delle raffiche. A bordo due giovani studenti Lubavitcher, riversi sulle fiancate, ridono rumorosamente, cantando a squarciagola, travolti da una gioia panica.
Per quanto le severe regole Chabad non permettano di bere alcoolici, paiono ubriachi. Le loro camicie bianche sono zuppe e appiccicate alla pelle, i capelli neri incollati alla testa, le braccia abbandonate fuoribordo, tentano senza forza e senza vera convinzione di remare nell’acqua agitata dalla corrente. Non sembrano curarsi del fatto che stanno andando alla deriva. Né, se è per questo, di dove stiano andando.
Giovanni sbatte le palpebre incredulo e si ferma a osservare la visione, l’assurda contraddizione di quell’oggetto e di quelle persone su quell’oggetto in quel luogo. L’immagine è surreale. Magica. Come il quadro di un acquatico Chagall. Un cortocircuito visivo.
Ma, come insegna il pensiero Chabad, che i due giovani chassidim sono venuti ad apprendere nella nuova comunità, l’uomo non è né statico né passivo né dipendente da altri per unirsi a Dio. Il Tanya, il testo sapienziale il cui nome originale è Likkutei Amarim, analizza con estrema sottigliezza quello che è il conflitto interiore dell’individuo e la via per risolverlo.
Che c’è di surreale, o di contraddittorio, nella liberazione che scaturisce dalla gioia di esistere liberi e senza costrizioni? Esistono vie migliori di altre per giungere a Dio e all’interezza dell’io? Forse che un buffo canotto di plastica colorata, recuperato chissà dove e trascinato dalla corrente, ha meno significato di infinite ore di preghiera e meditazione? Dunque, se pure Chabad attinge alla sapienza della Kabbalah per elevare la mente al di sopra delle emozioni, perché non potrebbero essere le emozioni il mezzo per elevare la mente? Perché non potrebbe essere quella la via per risolvere il conflitto fra la bellezza dell’esistenza e il rigore della morale? Hanno pensato questo i due giovani chassidim nel gonfiare il canotto, variopinto come la città corruttrice in cui sono da poco arrivati, nel salirci a bordo e nel lasciarsi trascinare dal canto e dalla corrente? Così si è rivelato loro Dio e non nell’austerità della preghiera e della costrizione? Non sono ubriachi di vino. Sono ubriachi di vita.
Il canotto, col suo carico di libertà, è ormai avviato senza controllo verso lo sbocco del canale in laguna aperta. La macchia arancione, verde, gialla si rimpicciolisce perdendosi in laguna e il vento incorpora nella propria voce il canto e le risate.
Giovanni si asciuga pioggia e lacrime che colano in rivoletti sul viso e una risata di felicità primordiale gli sale dal cuore, gli libera la gola, gli esplode dalla bocca, dalla pelle, dai capelli, dal corpo tutto intero e lo travolge. Non importa se acqua cade dal cielo e sale dal mare. Non importa se non ha riparo. Lui è ora acqua e vento. È pietra e cielo. Qualcosa dentro di lui ha mollato gli ormeggi e veleggia libera verso il mare aperto delle possibilità. Senza più essere né statico, né passivo, né dipendente da altri.
(C) by Francesca Diano RIPRODUZIONE RISERVATA
Da Fiabe d’amor crudele. 2013 Edizioni La Gru







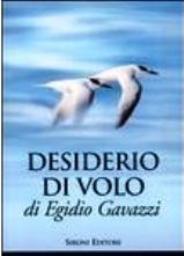

Commenti recenti