
Sergio Rodella, San Michele. Bronzo, acciaio, vetro
Tra tutte le arti, la scultura è forse quella che più presuppone l’artificio. E questa non sembri una tautologia. Poiché con “artificio” non intendo “fare arte”, che è il significato etimologico del termine e che è, esso sì, una tautologia, poiché “arte” è “fare” e l’artefice, l’artista, è “colui che fa”. Che materialmente crea attraverso l’abilità tecnica qualcosa che è sì materia, ma allo stesso tempo la materia la trascende. È la téchne dei Greci. Senza la quale non v’è poiésis, creazione. I due momenti essendo indivisibili e assolutamente interdipendenti. Tanto che nella sostanza sono un unico fare istantaneo.
Ed è proprio in questo misterioso trascendere la materia che sta il senso dell’arte. Che si rivela nella forma.
Intendo artificio nel suo senso più lato, come traspare dai suoi sinonimi di “magia”, “alchimia”, “mistificazione”, “finzione”. E “ingegno” e “trucco”. Fino a virare dunque, questo senso, verso il suo negativo. Poiché l’eccesso di artifizio, verrebbe da dire, diviene inganno. Eppure ancora, persino il valore deteriore contiene quel significato che è radice dell’arte. Inganno sublime. Tale, che è proprio in esso che si rivela la verità. Che solo può rivelarsi in un’estrema metafora del reale.
Il linguaggio dell’arte non è mai diretto, ma sempre obliquo, come obliquo è lo sguardo del dio.
Alois Riegl afferma che l’arte è una gara con la natura. Non una semplice imitazione, si badi, ma una gara. Come la natura crea le sue forme, così l’arte crea le proprie, in una sorta di competizione, secondo leggi che variano col variare del sentimento che informa di sé le diverse epoche. Ma afferma anche che, nella sua più profonda essenza, l’arte nasce dal bisogno radicale di armonia che l’uomo ha in sé.
Dunque, nemmeno l’arte più “naturalistica” è naturale, se non per il fatto che a crearla è l’uomo e l’uomo è parte della natura. L’arte è una sorta di natura parallela. Un diverso percorso secondo cui la natura opera nel suo manifestarsi.
Ma ciò che fa l’arte arte, è il senso della forma, persino quando questa forma sia in apparenza assente, come nell’arte astratta. E l’arte della forma per eccellenza è la scultura. Come ben sapevano i Greci.
La scultura non può prescindere dallo spazio. Ma quale spazio? Esiste uno spazio oggettivo entro cui si muovano le forme? Sono davvero separate le forme dallo spazio che le circonda? Ed esistono forme oggettive? O non è, lo spazio con le forme che contiene e che anzi lo creano, la percezione assolutamente soggettiva di una realtà parziale e indimostrabile? Lo sguardo che l’uomo, ciascun uomo, posa sul mondo e lo trasforma dentro di sé?
Dunque la scultura, non diversamente dall’architettura, è arte dello spazio. L’una ne è fulcro e centro, di quel vortice che se ne diparte, l’altra, all’opposto, è il tentativo di creare delimitazioni a un infinito che come tale è privo di riferimenti e dunque temibile.
Certo, accanto ai primi balbettii dell’arte, a quei primi segni decorativi, nati da chissà quale misterioso impulso, senza altro scopo che l’ornamento di corpi e di oggetti, uno dei primi gesti che l’uomo fece fu quello di delimitare uno spazio in cui rifugiarsi. Dalla caverna alla basilica di San Pietro il passo non è poi così lungo. Gli strumenti che l’uomo ha usato all’inizio per fare arte erano oggetti quotidiani, destinati ad altri usi, ma la destinazione a un uso non pratico ha trasformato il loro significato.
Noi abbiamo, della materia che costituisce il nostro corpo e gli oggetti che ci circondano, una percezione totalmente soggettiva. Siamo certi di toccare, di vedere, di sfiorare una sostanza, ma non comprendiamo immediatamente che le sensazioni che ci restituiscono i sensi sono solo una parte limitata di quello che veramente è. Poiché i nostri sensi sono limitati e percepiscono una realtà limitata. Il tatto non percepisce lo spazio che separa le molecole e gli atomi, la vista non percepisce le gamme dell’ultravioletto e dell’infrarosso e anzi ciò che vedremmo, se cadesse l’illusione data dai sensi, ci terrorizzerebbe. L’udito non percepisce gli ultrasuoni. Eppure gli ancora grossolani strumenti della scienza ci dicono che tutto questo esiste al di là della nostra percezione.
Ma esiste anche una sostanza sottile, vibratile, luminosa, che con un termine grossolano potremmo chiamare pura energia. È di questo stato originario della materia che si occupa l’arte. Lo può fare proprio perché tutta la materia come noi la conosciamo, alla sua origine non è che energia in forme più o meno addensate e coagulate e l’arte non si ferma al particolare, ma ha sete di universale. L’arte cerca l’origine. Da cui è scaturito il mondo.
Non c’è arte senza questa ricerca alla fonte e anzi, non c’è arte in cui questa vibrazione luminosa non sia percepibile.
Ma, proprio perché è di scultura che si parla, è bene osservare che quanto si diceva all’inizio, e cioè l’artificio come supremo e sublime inganno, si rivela nella scultura quanto mai in altre forme dell’arte.
La scultura, che è forma tridimensionale ha, quand’anche fosse un’opera informale, come ispirazione, se non come modello, le forme del mondo visibile. Che sono tridimensionali. Tuttavia, persino una perfetta riproduzione di un modello organico o inorganico, se di arte si tratta, lo trascende, a cercarne l’essenza per renderla percepibile. Non solo dunque si avvale, la scultura, delle tre dimensioni che conosciamo e all’interno delle quali ci muoviamo, ma quelle dimensioni usa per liberarsene.
Ci sono scultori, rarissimi oggi a dire il vero, che fanno di questo paradosso lo scopo della loro arte. È a questa esigua schiera che appartiene Sergio Rodella.
È naturale che per la cultura da cui nasce e in cui si muove sia un outsider. Non è semplice rendersi sordi al fragore delle mille direzioni verso il nulla che assediano da ogni parte. E non è un outsider perché si ostina a salvare la forma dove e quando questa pare abbia perso ogni interesse, ma perché la Forma la vede e ne percepisce la straordinaria potenza originaria. La potenza dell’Idea che nella Forma si manifesta. Con una forza che fa tremare.
È un artista di incredibile cultura, oltre che un meraviglioso, quasi ossessivo, conoscitore delle tecniche e dei materiali, che tra le sue mani perdono in parte la loro natura e diventano colore puro, materia molle che si scioglie in colore intriso di luce eppure, quando ti parla, capisci con quale umiltà e reverenza si accosti alla sua arte. Di alcune opere afferma di non sapere cosa abbiano in sé veramente. Quale sia il loro significato. Ma non è falsa modestia, che sarebbe fuori luogo, ma piuttosto l’atteggiamento di chi sia assolutamente cosciente di come un’opera d’arte sia un mistero, al di là dell’intento consapevole dell’artista, per quanto esperto e consumato.
L’arte, tutta l’arte, al di là degli artisti, è una forma di misticismo. Una forma di ascesi. E di conoscenza.
Perché attraverso l’illusione trascende l’illusione che è il mondo, per approdare alla verità. Difatti ha il suo prezzo. Molto alto per chi ne è posseduto.
L’artista è l’artefice. Senza il suo fare, non vi sarebbe arte. Ma è anche un mezzo e non può sottrarsi a questa dominanza, a questa padrona imperiosa che non concede sconti o scorciatoie. E ti assedia la vita.
Ed è dunque una forma di conoscenza. Soltanto quando un’opera “si fa” la si conosce. Ma, nel farla, si conosce anche se stessi. E si conosce l’universo di cui quell’opera è il punto di arrivo. E di partenza. In un circolo che, come il tempo del sacro, torna eternamente su se stesso.
L’universo di Rodella è non dissimile dall’iperuranio platonico. Le sue immagini vivono lì, perfette, assolute, portatrici di un valore simbolico e lontane. Ma chiedono di assumere una forma visibile. Quegli archetipi guidano la sua mente, le sue mani, il suo corpo, i movimenti dei suoi strumenti, fino a divenire materia visibile.
Non è certo un caso che il calco del Giorno di Michelangelo, il grande neoplatonico, vegli sui suoi sonni e domini fisicamente la sua testa.
Credo che, quando un’idea prende forma nella sua mente, insomma gli si manifesti, Rodella se ne senta posseduto e che senta di non potersi sottrarre al tradurla in una forma visibile. E che, man mano che l’opera prende corpo, gli si riveli veramente per la prima volta. Con una chiarezza abbacinante.
Questa “necessità”, questa luccicanza, è una sorta di destino di ogni opera d’arte. È così perché è così. Un rispecchiarsi solo su se stessa. Non può avere altro specchio se non la propria fonte archetipica.
Questo suo personale iperuranio è popolato di minotauri, di angeli e arcangeli, di volti senza corpo, di corpi acefali o senza volto, di forme in torsione e in tensione. Esseri tutti in uno stato di silenziosa e drammatica trasformazione.
Le sue figure sempre “stanno per”. Questo incoativo è il tempo che le coniuga. Dunque in questo sta la diversità rispetto alla concezione antica del Bello, avulso e distaccato dal dramma. La diversità è nell’irruzione del dramma che le spacca e le frantuma e le fa umane.
Eppure lo spazio che le contiene è quello dell’assoluto.
L’arte, perché verità, prescinde dallo spazio e dal tempo, perché spazio e tempo sono solo una convenzione umana. Ma ogni artista ha il suo spazio e il suo tempo.
Il tempo di Rodella è l’istante. Che presuppone un prima e un poi. Ma le sue figure sono sempre colte in quell’infinitesimo di istante “prima che” o “dopo che”. Esseri nell’atto della metamorfosi. Come l’abbagliante Minotauro, il cui vero corpo, che si sfa e allo stesso tempo si rapprende in luce, emerge dalle spoglie di una pelle che è una corteccia. Reale e metaforica. Come un serpente che muti pelle. E mi vien da pensare ad Apollo Ptokòs, Apollo nella sua forma sotterranea e atra di Pitone, Dio ctonio, che è altra faccia del Dio della luce. Perché è dal buio che nasce la luce.
Quasi sempre queste figure sporgono il petto o il ventre in avanti, o si ripiegano su se stesse, si torcono, si tendono, si spaccano. Ma non perché il movimento renda “bella” la scultura, piuttosto perché stanno lentamente emergendo da un sonno senza tempo, stanno cercando il loro posto nello spazio.
Certo, vi sono ovunque citazioni classiche, lezioni antichissime non dimenticate, ma il come tutto questo si rapprenda a creare un linguaggio assolutamente nuovo e libero da ogni condizionamento è frutto di una trasformazione individuale che è linguaggio di alchimista. Frutto di come quella energia vibratile e luminosa, di cui si parlava prima, si coagula a formare queste creature di marmi e pietre e metalli e resine. Dallo sguardo inquietante e mai immobile.
Dunque, come in ogni arte nata dalla perdita dolorosa dell’antico centro, cioè da quella che in Occidente, subito dopo i Greci, dovremmo chiamare arte moderna e che ha il suo culmine nel primissimo Barocco, il linguaggio è contraddittorio e doppio, in una tensione di estremi che in apparenza non si conciliano: da una parte l’assoluto della forma, che si manifesta nella luminosità pulsante dei suoi contorni, dall’altra l’esserci nell’istante, l’ex-sistere, l’essere, l’emergere nel mondo con il dramma che è l’esistenza di ciascun uomo.

Sergio Rodella, Salomone. Marmo, piombo, oro
Guardate il Salomone. Ieratico, chiuso, distante, quasi egizio. Ma la forma chiusa si spacca in uno iato da cui trabocca in rivoli la sofferenza. Materialmente Rodella ha fatto scendere fiotti di bronzo fuso da quella spaccatura. Che si sono riversati attraverso gli occhi e coagulati in eterno. Trasformandosi in oro.
Dunque, da una dimensione in cui è annullata l’esistenza dello spazio-tempo, alla dimensione spazio-temporale, all’eternarsi di nuovo in una dimensione assoluta. Perché questo Salomone, che è l’Idea stessa della conoscenza, si risveglia da se stesso e si fa uomo e, come tale, proprio perché questo è il prezzo della conoscenza, si carica del gravame della condizione umana. E quelle roventi lacrime di piombo fuso che ne sono il frutto, si trasformano alchemicamente in oro. Anche gli esseri immortali, nell’universo che noi oggi abitiamo, soffrono della sofferenza umana quando ne vengono a contatto, ma ne indicano il valore salvifico e purificatore. Dalla materia grezza alla purezza e alla liberazione.
Piombo. Oro. Ancora una volta dal buio alla luce. Intendendo il buio come luce in potenza.
Poi ci sono gli Angeli.
Rodella è un mistico. La via del mistico è dura, faticosa, irta di dubbi e incertezze e si può percorrere in molti modi. Anche con scalpelli e sgorbie. Mistico è colui che attraverso la materia giunge allo spirito. Che anzi si immerge nella materia perché è in essa che vede l’impronta dello spirito. Termine che oggi si teme di usare. E sa che solo così vi può giungere. Perché è questo il senso della vita umana.
Ogni obiettivo raggiunto non è che un gradino in più che si è salito. Non ci si pone il problema di quanti ancora ne restino. Li si sale e basta, perché l’unica certezza è che alla fine, per lontana che sia, ti attende la visione di ciò che ti fa assetato.
Gli Angeli e gli Arcangeli. Gli annunciatori. Annunciatori della metamorfosi.
Ed è così che tutto questo vibrar di ali e torcersi e pulsar di forme e sventagliare di colori canta la forma nel suo farsi. Le loro ali, i loro corpi di maschio e femmina insieme, sono il centro di quel vortice spaziale che lo spazio lo genera. Ma è lo spazio come lo vedevano i Celti, “il cui centro è ovunque e la circonferenza in nessun luogo”.
Sono angeli che han tutta l’aria delle Nikai, pronti sempre a decollare o a planare e rumorosamente fruscianti.
Tutto questo sonante movimento però, in questo universo di Rodella, questo movimento che cerca la forma proprio sfacendo la sostanza opaca in pura energia e dunque trascendendola, a un punto s’acquieta. Attraverso due passaggi. Il primo è il Silenzio.
Questo Angelo s’è spogliato delle ali e le ha appese ad un supporto, tal quale fa l’eroe nell’appendere le proprie armi dopo la battaglia. Le ha appese ed ha appeso se stesso, a testa in giù, come l’immagine dell’Appeso nelle lame dei Tarocchi. Questa forma simbolica rappresenta l’iniziazione e l’Appeso è l’iniziato. Il sacrificio consentito perché si possa accedere a diversi e sempre più alti piani di coscienza. È un oscuro e silenzioso maturare di una nuova nascita, l’atto finale prima della definitiva trasformazione, in cui ogni individuo si fonderà col Tutto, divenendo uno col Tutto.
L’ultimo e definitivo passaggio è il Cristo morto. Qui ogni contraddizione degli opposti si annulla. Buio e luce sono una sola cosa, poiché il nero assoluto del marmo è talmente intriso di luce, che culmina nella vibrazione dei capelli e della barba, da non essere più nero, non più l’opacità del buio, ma quell’oscurità abbagliante di luce che è dio.
E ogni movimento, ogni torsione, ogni spaccatura e ogni dramma s’annulla in un’immobile compostezza che non è rigidità o blocco del movimento, ma la “non necessità” del movimento, poiché questo Cristo è il Motore Immobile. È la divina serenità del Buddha, la sublime quiete di dio da cui tutto emana e a cui tutto torna.
Copyright by Francesca Diano (C) RIPRODUZIONE RISERVATA






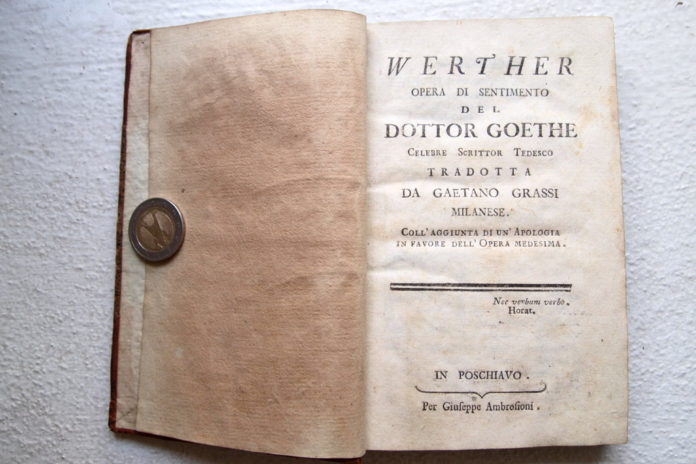


Commenti recenti